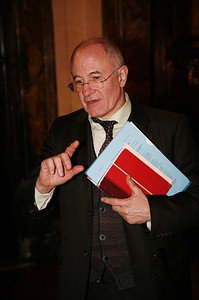LA REALTÀ COME SEGNO E LA SFIDA DEL CONOSCERE
Partecipano: Rémi Brague, Docente di Filosofia all’Università Sorbona di Parigi e all’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera; Costantino Esposito, Docente di Storia della Filosofia all’Università di Bari. Introduce Giovanni Maddalena, Docente di Filosofia Teoretica all’Università degli Studi del Molise.
Il testo dell’incontro è pubblicato nel libro “La conoscenza è sempre un avvenimento”, edizioni Mondadori Università.
GIOVANNI MADDALENA:
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo incontro filosofico dal titolo “la realtà come segno e la sfida del conoscere“, nel quale dialogheremo con i nostri illustri ospiti: prof. Rémi Brague e prof. Costantino Esposito. La filosofa come sapete è una forma per il rapporto con la realtà, sulla natura della quale poi sentiremo anche l’opinione dei nostri ospiti, ma che certamente ha come suo centro la conoscenza, che è il tema di questo Meeting. Del resto, poiché la conoscenza è l’attività propria dell’uomo, ogni uomo è un po’ filosofo, quindi è giusto che siamo così in tanti, però a tutti chiediamo l’attenzione e un paragone sincero tra ciò che i nostri ospiti diranno e la propria esperienza del conoscere. L’incontro è una specie di intervista: ci sono cinque domande, le prime due più impegnative, le altre spaziano invece su vari temi della filosofa. Risponderanno alternativamente i nostri due ospiti che vado a presentare brevemente. Rèmi Brague insegna Filosofia medioevale e araba alla Sorbona di Parigi, e Filosofia della religione alla Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco. I suoi lavori sono stati tradotti in molte lingue, soprattutto il lavoro che lo ha reso noto al grande pubblico, Europe, la voie romaine, tradotto in italiano come “Il futuro dell’occidente”, dove introduce l’idea che l’Europa sia debitrice soprattutto alla Romanità, nel senso della capacità romana di essere il punto di trasmissione di culture più ampie della propria, come quella greca ed ebraica. Trovate in tutte le librerie il suo ultimo libro Il Dio dei cristiani, che è uscito in Italia nel 2009 e sfata alcuni luoghi comuni sul cristianesimo e alcune altre religioni e pone l’accento sull’esperienza singolare del rapporto con Dio. Costantino Esposito è professore di Storia della filosofia presso l’università di Bari, è noto per i suoi studi su Suarez, Hegel, Agostino e Kant, del quale ha curato per Bompiani nel 2004 la nuova traduzione della Critica della ragion pura. La sua formulazione del canone kantiano, la sua interpretazione della modernità sono un punto di riferimento obbligatorio per gli storici della filosofia. Nel 2009 ha pubblicato con Laterza il manuale di filosofia per i licei intitolato Filosofia, che ha il grande merito di dare uno sguardo sintetico su quello che William James chiamava il centro di ogni filosofo, e di tenere aperte le domande fondamentali da cui la filosofia nasce. E’ noto al pubblico del Meeting anche per le conferenze che ha organizzato e tenuto. Incomincio quindi con la prima domanda. La prima domanda riguarda il tema del Meeting, la conoscenza come avvenimento: nella filosofia otto-novecentesca il problema della conoscenza è stato quello di riunificate un oggetto e un soggetto ormai definitivamente separati fra di loro. Questa divaricazione sembrava essere in qualche modo insuperabile, cioè da un lato c’è l’oggettività dura, quella che si può misurare, dall’altra invece c’è la soggettività intesa come una interpretazione arbitraria o un sogno consolatorio; da un lato il sapere, dall’altro il credere. Quindi la prima domanda è questa: che cosa significa per voi che la conoscenza parte sempre da un avvenimento, si sviluppa come avvenimento e soprattutto la parola avvenimento può riunire i due poli della conoscenza, cioè il soggetto e l’oggetto che sono stati tenuti così separati? Incomincia il prof. Brague.
RÉMI BRAGUE:
Grazie Alla tua domanda non risponderò in maniera diretta, ho solo bisogno di un po’ di distanza storica. Farò soltanto due osservazioni per chiarire il contesto della domanda e di una possibile risposta. Allora la prima.
Nell’ottocento, la riflessione dei filosofi, e anche di qualche scienziato, sulla loro pratica di investigazione scientifica, è sfociata in un paradosso. Negli anni 40 un francese, Augusto Come, aveva già proposto come regola generale che “noi non possiamo capire i fenomeni, ma soltanto scriverne le leggi” Questo lo fa la fisica in un linguaggio matematico; ma i fenomeni non possiamo capirli. Lo potremmo, se solo fossimo capaci di saperne le cause; ma le cause rimangono r rimarranno sconosciute. Una generazione dopo il paradosso a ui alludevo venne formulato da un altro francese, Claude Bernard: Era un fisiologo, conosciuto soprattutto per la sua scoperta della funzione del fegato. Ha scritto una introduzione allo studio della medicina sperimentale. Bernard dice, in questa opera, che lo scopo della scienza non è la conoscenza stessa quanto piuttosto la possibilità di un intervento sui fenomeni. Quando conosciamo le leggi dei fenomeni noi possiamo diventare loro maestri e, tuttavia, non conosciamo le loro cause. La potenza umana è più estesa della conoscenza, di qui nasce questa frase straordinaria in francese “l’homme peut donc plus qu’il ne sait, l’uomo può più di quello che sa, la scienza moderna ci ha costretti a rinunciare alla pretesa di capire la natura che ci circonda. Noi possiamo soltanto agire su di essa, questa possibilità compensa e fa dimenticare un sentimento fondamentale di estraneità nel mondo. Lo sviluppo moderno della tecnologia si accompagna al ritorno e alla crescita nell’ottocoento di un atteggiamento che assomiglia a quello dei cosiddetti “gnostici” dei primi secoli del cristianesimo: siamo qui per caso, siamo come naufraghi buttati in un mondo indifferente. In un mio libro ho citato parecchi testi che testimoniano di tale sensibilità in tutta la letteratura europea ottocentesca, e ne trovo sempre più.
Seconda osservazione è questa: la filosofia tedesca del tardo ottocento ha voluto distinguere tra una scienza dura che ricerca le leggi dei fenomeni e la storia che ha a che fare invece con gli avvenimenti che non si ripetono, che non esistono se non una sola volta. Per noi il processo della conoscenza, anche quella delle leggi della natura è un avvenimento, siamo noi stessi avvenimenti, viviamo una vita che non ritornerà più, una vita nella quale ogni momento costituisce un fatto unico. Nella nostra via i fenomeni non si ripetono mai. Due battiti del mio cuore non solo lo stesso; il secondo è più lontano dalla mia nascita e più vicino alla mia morte, rispetto al primo. La conoscenza che corrisponde al carattere unico del suo oggetto si può chiamare esperienza. Questa parola è pericolosa, nonostante la somiglianza delle parole l’esperienza non ha niente a che fare con l’esperimento scientifico. Quest’ultimo decide di prescindere da tutto ciò che è irripetibile e di conservare soltanto ciò che è permanente. Fa astrazione della data, dal luogo, dalla personalità dello scienziato ecc. in parole povere fa astrazione di tutti gli elementi di cui si potrebbe narrare la storia, ma che risultano indifferenti per la legge generale e si possono dimenticare. L’esperimento funziona come un metodo dello “scordarsi”, mentre invece l’esperienza è un metodo del “ricordarsi”. E’ importante essere consapevole della differenza tra esperienza e esperimento perché è forte la tentazione di scambiare l’una per l’altra. Dall’ottocento si incontrano concezioni della vita intesa come esperimento. Il filosofo inglese John Stuart Mill, nel suo famoso saggio sulla libertà apparso nel 1859 dice che abbiamo bisogno di esperimenti di vita “experiments of living” La ricerca di tali esperimenti è diventata come una regola nel corso dell’ottocento prima nei circoli ristretti dei ricchi scapigliati che si consideravano “artisti”, adesso da tutti i cosiddetti “bobo” bourgeois boheme.
Se si vuol dire che abbiamo bisogno di un po’ di fantasia, di creatività allora va bene. Tale atteggiamento si può spiegare storicamente e forse giustificare come reazione contro la morale vittoriana. Ma, se si prendono queste parole nel loro significato rigoroso allora l’espressione è contraddittoria, la vita è quello di cui non si può fare un esperimento. Non mi riferisco in questo caso alla vita come fatto biologico quanto piuttosto alla vita che conduciamo in termini greci non alla zoè, ma al bios. E non mi riferisco neppure alla legittimità o illegittimità morale dell’esperimento nel campo della biologia, nella cosiddetta bioetica. Mi riferisco invece alla stessa possibilità di sperimentare con la vita che facciamo e che non tornerà. Abbiamo una memoria che trattiene quello che è già capitato, e anche il genere umano ha una memoria, quello che chiamiamo la storia. E per questo è semplicemente impossibile sperimentare nel senso rigoroso di questa parola nel senso di esperimento con la vita.
COSTANTINO ESPOSITO:
Io sono facilitato dalla puntuale introduzione di M. Brague nel dare la mia risposta e quindi ne approfitto per fare un piccolo paso indietro dicendo che detto in estrema sintesi, il problema della conoscenza che Giovanni Maddalena metteva a fuoco all’inizio, credo che dipenda ancora dal modo consueto di impostare la questione che abbiamo ereditato da Kant, che direi con due frasi, mi perdonerete la brevità. “si conosce solo ciò di cui si fa esperienza, ma l’esperienza è già sempre predeterminata a priori dal soggetto” o in altri termini la conoscenza o è scienza esatta, misurativa o non è. Ma questo vuol dire che non ci sarà mai possibile fare esperienza di ciò che trascende o supera le condizioni di misurabilità o come anche Kant lo chiama l’incondizionato, per esempio il mio io, del mio io non potrò mai fare esperienza, so come funziona la mia mente nell’assemblare i fenomeni, ma di chi sia colui che assembla non posso dir nulla. Come non potrò dire nulla del mondo come una totalità e non semplicemente come la serie misurabile di causa effetto, effetto causa, causa effetto. Come pure di Dio l’incondizionato non potrà mai cadere nella mia esperienza e tuttavia questa soluzione kantiana al problema non soddisfa neanche Kant. Perché come lo stesso grande tedesco, grande e tragico tedesco osservava, l’attesa dell’incondizionato, la conoscenza dell’incondizionato è la stoffa della ragione. Per sua natura la ragione tende a porre domande ultime sulla realtà sull’esere sulla totalità sull’infinito. E’ come dice lo stesso Kant se noi togliessimo alla ragione queste domande la ragione non esisterebbe più. Vorrei notare che la ragione pone queste domande non a caso, ma perché vuole conoscere tutto, cioè mira per sua natura a toccare con la sua comprensione l’essere, a penetrare a far sua la realtà intera. Ma qui dice sempre Kant, la ragione è segnata da lo chiama “un destino particolare”; da una parte non può mai smettere di porre queste domande ultime, ma al tempo stesso la ragione è incapace di dare risposta a queste domande e qui hanno modo di vendere, questo è lo status questionis, qui Kant decide esattamente a questo punto Kant fa la suo opzione, quella che ha fatto epoca fino ai nostri giorni, cioè una volta individuata la traiettoria della ragione, cioè l’apertura infinita delle sue domande, e una volta detto che la ragione non potrà mai giungere a conoscere il suo obiettivo, semplicemente perché questo obiettivo non si da nello spazio e nel tempo, allora tale traiettoria deve essere curvata verso se stessa per trovare, non più fuori dalla ragione, ma all’interno della ragione, come una pura idea della ragione, ciò che la ragione illusoriamente pensava, credeva di poter trovare come altro da sé. Certo, secondo kant non si potrà mai negare l’esistenza di Dio dell’anima, così come non la si può affermare, entrambe le chances, entrambe le possibilità sono al di fuori della nostra portata. Tuttavia, questo è quello che mi interessa di più, non è tanto la negazione della totalità dell’infinito quello che interessa qui, ma il fatto che l’infinito viene ripensato da Kant come un prodotto della ragione, come ciò che la ragione stessa si dà, che non gli viene dal di fuori, ma è essa stessa che produce. Quindi l’oggetto ultimo della ragione non è più trascendente ma rigorosamente immanente. E quando Kant afferma all’inizio della critica della ragion pura che “ho dovuto mettere da parte il sapere” cioè la conoscenza “per far posto alla fede” vuol dire che l’esistenza degli oggetti incondizionati, l’anima, il mondo, Dio, appunto non solo non la posso verificare, non posso verificare questa esistenza, ma ultimamente non mi interessa neanche. L’esistenza dell’infinito è poco interessante per la ragione perché alla ragione non interessa che l’incondizionato, l’infinito sia, ma solo che debba essere all’interno della ragione stessa. Sulla base di questa separazione il fattore avvenimento, di cui si parla qui al meeting, della conoscenza viene per così dire bruciato, mi sembra, nella misura in cui l’avvenimento della realtà è controllato a priori dai dispositivi della ragione, come ragione pura, cioè indipendente dall’esperienza. Ma velocissimamente vorrei dire che anche coloro che hanno cercato di opporsi da un punto di vista più realistico in senso però dogmatico a questa impostazione, non sembra abbiano dato una convincente alternativa, cioè l’anti kantismo in cosa consisterebbe: nel dire invece la realtà esiste senza l’io, cioè è un pezzo di mondo anonimo, neutro, senza un rapporto con l’io. E’ in qualche modo la riduzione positivistica della realtà. A me sembra invece, e chiudo, che l’avvenimento vada come un po’ salvato da queste due riduzioni quella trascendentale di Kant, nel senso appunto che è l’io che decide a priori delle condizioni di possibilità del dato, o quella positivistica, cioè che il dato c’è come un pezzo di mondo anonimo, senza di me, proprio perché la conoscenza è un rapporto che viene prima della dialettica soggetto oggetto prima non solo all’inizio, ma prima costantemente, originariamente, strutturalmente prima. Nella dialettica soggetto oggetto infatti, c’è già come un gioco delle parti prefissato, mentre il rapporto come avvenimento di conoscenza è come un venirmi incontro di un dato che mi sollecita, che mi attrae con la sua presenza, mi tocca, mi colpisce, mi provoca. In questo incontro la realtà viene all’evidenza e l’io viene chiamato ad essere in risposta a questo colpo della realtà. L’io si scopre in quanto anche egli dato con la realtà. In questo avvenimento la realtà si mostra come altra da me. E’ sempre prima di me, ma al tempo stesso, questa è la cosa che a me personalmente più interessa, la realtà chiede di me, cioè chiede di diventare mia.
GIOVANNI MADDALENA:
Come vedete si tratta di un lavoro impegnativo, però vale la pena. Le due precisazioni sull’esperienza e sul canone kantiano sono decisive per capire che cosa voglia dire la nostra esperienza del conoscere. Ancora sulla conoscenza: oggi la mentalità comune della filosofia, quella più in voga, è quella cosiddetta “naturalista”. Naturalista vuol dire sinteticamente “pensare che il mondo sia casualmente chiuso”. Questo viene affermato da tutti gli esiti più recenti delle filosofie di ogni matrice, sia di quella ermeneutica che di quella analitica, tanto per dirla in breve e molto imprecisamente. Questa mentalità naturalista sembra avere un doppio motore, da un lato l’empirismo di tipo positivistico, del quale Brague accennava in precedenza, dall’altro l’evoluzionismo. Siamo in un anno di anniversari, come ben sapete. In questa visione naturalista ciò che si perde è il fatto che l’incontro con la conoscenza, l’incontro con la realtà abbia una dimensione di segno. E d’altra parte chi volesse recuperare questa dimensione più metafisica, storica, viene immediatamente contrapposto alla tendenza scientifica. Quindi come ritrovare e se ritrovare, questa dimensione di segno? E all’interno dello stesso empirismo, dello stesso evoluzionismo, c’è la possibilità di parlare di segni o della realtà intesa in questo senso? Magari facciamo che questa volta incominci Esposito.
COSTANTINO ESPOSITO:
Ma direi così qual è la sfida del naturalismo che come diceva Maddalena, sembra essere la grande mentalità comune in tutti i campi che attraversa come rischio, come tendenza tutti i campi della ricerca filosofica, che tutto sia spiegabile come una realtà naturale. E questo per me comporta due problemi.
Primo problema: chiederei questa domanda: ci è possibile delimitare o precisare le dimensioni di questo tutto, tutto spiegabile come realtà naturale? Sappiamo bene che per un naturalista convinto del nostro tempo, naturalismo non vuol dire necessariamente materialismo. Vi faccio due esempi: ogni naturalista anche il più hard deve ammettere che abbiamo qualcosa come una coscienza, che si cerca tendenzialmente di risolvere i meccanismi cerebrali, una fisiologia, ma non ci si riesce, tanto è vero che anche naturalisti convinti parlano ancora di un mistero della coscienza. Oppure altro esempio, noi siamo capaci di formulare entità logiche o norme di valore morale che richiedono una giustificazione, una opzionalità che non è ricavabile soltanto dal procedimento delle scienze naturali. Allora io direi che quando il naturalista dice che tutto è spiegabile come realtà naturale, anch’egli fa una opzione e una scelta teorica rispetto al problema “totalità” Da una parte questo sta a dire che la totalità è un’esigenza insopprimibile, per la conoscenza, ma a me sembra che il naturalismo abbia troppa fretta di chiudere i conti, di dire che cosa sia questa totalità. Lascia meno aperto il campo a ciò che non è preventivabile dentro questa griglia.
Secondo problema: la natura, mi chiederei, è esattamente identificabile con l’oggetto delle analisi della scienza esatta? E ancora di più : che cosa permette di determinare un oggetto scientifico? Ancora più semplicemente: che cosa accade quando noi conosciamo la natura? Che cosa ci dice la natura? O per essere un po’ più critici: che cosa le facciamo dire noi alla natura? Per rispondere a questa seconda domanda vorrei semplicemente segnalare il fatto che sempre quando si conosce si ha a che fare con dei segni, che la realtà della natura è conosciuta da noi sempre come segno di qualcosa. Ma anche la nostra conoscenza è segno, mi spiego. Prima flessione: quando noi vediamo delle cose, degli avvenimenti, dei dati, è partendo da quei dati, arriviamo a formulare un’ipotesi di spiegazione, di quei fenomeni, cioè a ipotizzare una teoria, appunto la teoria è ciò di cui la realtà vale come segno, cioè rimanda come spiegazione a una teoria. E viceversa, anche quando noi facciamo una teoria, cioè una spiegazione del mondo, la nostra spiegazione può essere intesa come segno a sua volta della struttura ontologica, cioè dell’essere della natura stessa del mondo. In ogni caso, quando si tratta di segni è sempre inevitabilmente implicata la libertà dello sguardo del ricercatore, cioè la posizione di colui che compie una conoscenza. E mi permetto di rilevare che la posizione di coloro che affermano i naturalisti convinti, che la realtà naturale non è segno di niente, cioè dice soltanto il suo meccanismo interno, è tutto da dimostrare. E non è più tranquilla, più scontata della posizione di coloro che invece dicono o cercano di capire di che cosa ci stia parlando la natura. Ma vorrei fare ancora un brevissimo nota bene. Quando parliamo di segno verrebbe da chiedere: ma il segno è semplicemente una dimensione ulteriore, trascendente la conoscenza della natura? O può essere ritrovata anche nella scienza. Abitualmente si pensa che la scienza mira alla ripetibilità, è una procedura controllabile, misurabile, che si accontenta delle sue misure, stop. Dal canto suo invece la metafisica risponderebbe a una esigenza ulteriore di cui la scienza non può dare conto, ma di cui la scienza potrebbe anche fare a meno. E difatti mi sembra che molta filosofia contemporanea ha cercato di risolvere il problema differenziando scienza naturale, metafisica, e cercando poi di gettare dei ponti. Proviamo invece a verificare il contrario. Chiediamoci se una conoscenza, una conoscenza esatta, scientifica, determinata, controllabile, sarebbe mai possibile se alla sua origine e al suo fondo non ci fosse permanentemente l’accoglienza della realtà, cioè quella posizione di disponibilità a seguire l’attrattiva che il reale esercita sulla nostra ragione. E anche l’ostinata ricerca di leggi attraverso cui conoscere e possedere il mondo, è un nostro tentativo che però in qualche modo risponde ad un invito della realtà. Anche quando noi scopriamo una ripetibilità nella natura, qualche cosa che può sembrare meccanico che non ha più bisogno di me, della soggettività di colui che l’ha scoperta, bene direi che anche questa ripetibilità è una intelligibilità della realtà di cui noi ci accorgiamo quando la raggiungiamo. Ma una volta che lo scienziato arriva a capire la legge ripetibile, si rende in certo modo conto che quella intelligibilità era già presente perché lui la potesse scoprire. Insomma, anche, e chiudo, anche nel prodotto più esatto, più determinato, più tecnico della mia conoscenza, è già presente all’opera un avvenimento, l’avvenimento di un incontro secondo la bellissima frase di Don Giussani che Carmine Di Martino ha richiamato l’altro ieri “un incontro tra un’energia umana e una presenza” E questo costituisce un vero e proprio metodo di conoscenza, cioè una strada in cui accade il mio rapporto con la realtà che può avere flessioni e applicazioni diversissime, modalità anche diametralmente opposte ma che in qualche modo è dentro questa avventura fondamentale della scoperta. Insomma, il tutto, la totalità l’infinito che è il termine ultimo delle nostre domande, non è semplicemente qualche cosa che è al di là dell’esperienza, ma dentro di essa, al fondo di essa, e in qualche modo ne costituisce il segreto motore.
RÉMI BRAGUE:
C’è nella scienza odierna un paradosso: questa scienza è sempre più esatta, ma sempre meno interessante. Mi spiego con una distinzione fra tre significati della parola “interessante”.
Il primo significato è quello di ciò che ci fa guadagnare qualcosa. Questo qualcosa possono essere i soldi, come quando si parla dell’interesse di un capitale. Ma quello che guadagniamo può essere più importante per esempio la felicità o la stessa esistenza.
Il secondo significato di interessante è quello di fascinoso, attraente avvincente. Un paesaggio, un’opera d’arte sono interessanti ma questo tipo di interesse non è lo stesso di quello definito in precedenza. Kant, nella sua terza critica, quella in cui sviluppa la sua estetica, parla del piacere estetico, di ciò che sentiamo davanti al bello, come di un piacere disinteressato.
Il terzo significato di interessante è, secondo me, il più autentico: esso corrisponde a una possibile etimologia. Il verbo latino interesse vuole dire partecipare, essere in mezzo a qualcosa. L’interessante è ciò che si deve attraversare per giungere a se stessi. L’arte al suo apice è interessante in questo terzo significato. Come esempio, possiamo pensare al teatro, una commedia può essere molto buffa, affascinarci, ma non ci dice niente su noi stessi. Allora è interessante nel secondo significato soltanto. Non accade lo steso in una grande tragedia, per esempio. In questo caso si può sempre dire come il poeta latino : de te fabula narratur, la storia che si racconta è la tua. Quello che si svolge sulla scena non è un oggetto ma costringe il soggetto a un esame di coscienza. Questo accade quando si leggono la Divina Commedia, il Don Chisciotte, il Faust, i Fratelli Karamazov, ecc. Allora, per la concezione premoderna della conoscenza, cioè quella antica o medioevale, la natura era interessante nel senso più autentico di questa parola. La contemplazione della natura ci insegnava quello che siamo e quello che dobbiamo fare per essere più umani. Lo scrive, per esempio Seneca nella prefazione alle sue ricerche di fisiche, lo studio dell’astronomia, scrive il filosofo latino, permette all’anima umana di scoprire il suo vero luogo d’origine nei corpi celesti. Altri dicevano, con il Timeo platonico: dobbiamo imitare l’ordine splendido dei fenomeni celesti per porre ordine anche noi nelle nostre vite. Questa concezione è irrimediabilmente tramontata e rimane l’uomo moderno davanti a il grande paradosso a cui alludevo: la conoscenza della natura che gli dà la scienza moderna è mille volte più vera è mille volte più efficace di quella pre-moderna, ma non è per niente affatto più interessante nel senso che ho appena detto. La scienza moderna, alleata alla tecnologia che essa rende possibile, è sommamente redditizia. E per questo interessante nel primo significato. Un esempio: la vaccinazione a cui molti in questo auditorium devono la vita stessa, questa conoscenza scientifica è anche sommamente affascinante e allora interessante nel secondo significato, si pensi agli spazi dell’infinitamente grande o dell’infinitamente piccolo, a tutto ciò che ci mostra il telescopio o il microscopio per non parlare di strumenti ancora più precisi. Tuttavia, questa conoscenza non è interessante nel terzo significato. Prendiamo come esempio il caso più difficile: le scoperte che riguardano l’uomo per esempio quelle della paleontologie o della preistoria (in un’ora parla Yves Copains in questo convegno il grande specialista francese della palentologia umana ). Tutto questo è affascinante, ma non ci dice niente sui problemi che abbiamo da affrontare nella vita. Non ci dice niente del cosiddetto “senso della vita”. Più semplicemente, benché ci dica moltissime cose sull’uomo come specie vivente, non dice niente su quello che dice “io”. Non dice nulla di quello che io dovrei fare. Davanti a questo problema ci sono due tentazioni opposte.
La prima: possiamo conservare la scienza e scordarci del desiderio di capire, possiamo fare come se l’uomo potesse vivere senza la brama di senso. Allora la scienza deve essere l’unica sorgente e l’unico luogo di verità. Questa tesi, attenti, non la sostiene la scienza che non dice niente di se, la sostiene l’uso ideologico della scienza, secondo cui potremo guarire l’uomo dal desiderio vano di senso. Si produce così una specie di mutilazione.
La seconda tentazione è il rovescio della prima: possiamo conservare il desiderio di senso e scordarci della scienza, possiamo rischiare il ritorno a una visione pre-moderna del mondo superata nel campo della scienza, ma finora presente nel campo del mito. Si produce allora una specie di schizofrenia, si difende una visione del mondo che sappiamo essere illusoria. Un esempio: la terra. La terra era per il mito greco una dea, per la scienza moderna è un pianeta. Dopo la modernità, non possiamo vederla più come una dea, purtroppo, possiamo illuderci, fare come se, e idolatrare la terra e chiamarla come lo fa qualche ecologo estremista americano, gaia. Questo lo faceva già Auguste Compte, il già nominato Auguste Compte, alla fine della sua vita. Chiamava la terra il “grande feticcio”.
La terza via sarebbe una conciliazione tra la conoscenza scientifica dell’universo e l’interesse vitale. Questa conciliazione la potremmo cercare nel campo della fede. Appare interessante che né l’uso ideologico della scienza, il cosiddetto scientismo, né l’illusione del mito, accettano la fede, e specialmente quella cristiana. Per l’ideologia scientista credere è soltanto un m odo debole o scarso del sapere. Da qui la concezione positivistica della religione come spiegazione primitiva dei fenomeni naturali, una concezione che non corrisponde a quello che ci dice l’etnologia della regione dei popoli cosiddetti primitivi. Anche la visione mitica del mondo non accetta la fede perché la fede sa che crede. Il mito crede che sa o si illude sulla verità di quello che crede. La fede si sviluppa dove abbiamo a che fare con cose interessanti nel terzo senso che ho appena delineato. La fede non si oppone alla ragione, la fede è la ragione che prende come oggetto le sue condizioni di possibilità. La fede non ci dice nulla sulla costituzione della realtà naturale. Quindi non si muove nello stesso piano della scienza. Per esempio la fede nella creazione non ci dice come è fatto il creato, neppure come venne fatto. Ci lascia liberi di cercare e di costruire modelli di intelligibilità. Ma ci dice la fede qualcosa di più fondamentale, ci dice che c’è una intelligibilità delle cose. Ci dice che il mondo è immerso in una dimensione di carattere razionale: all’inizio, dice il quarto Vangelo, c’era il Logos, c’era il Verbo, c’era la ragione. Ci dice inoltre che questa intelligibilità si radica in una libertà che è la sorgente della nostra, quella divina, una libertà a cui la nostra libertà può avere accesso, una libertà con cui la nostra può entrare in dialogo.
GIOVANNI MADDALENA:
Cambiando tema, a proposito di libertà, Pier Paolo Pasolini diceva, trentacinque anni fa, che si è affermata una versione ultima del potere manipolatore del desiderio. E’ un potere unico in tutto il mondo, un potere che pre-determina la conoscenza, anzi pre-determina il desiderio, quindi ci dice quello che dobbiamo desiderare, quello che dobbiamo pensare. In questa visione apocalittica, nella quale egli scriveva potere con la p maiuscola, la chiesa non è più necessaria. Siete d’accordo con questa visione, con questa definizione di potere e in che cosa pensate che consista la possibilità di libertà per il singolo essere umano?
RÉMI BRAGUE:
Sinceramente non conoscevo questo pensiero di Pasolini e sarebbe difficile discuterlo sul serio senza un riferimento preciso alle sue argomentazioni. Mi sembra il sintomo di una certa inflazione del concetto di potere nel solco di Michel Foucaut che interpretava così ogni fenomeno sociale come strategia nascosta del potere, allora farò soltanto due osservazioni brevissime. La pedagogia moderna o piuttosto quel tentativo tipicamente moderno che è la pedagogia, la volontà di ridurre a un metodo l’educazione dei giovani, già conosceva questa caratterizzazione del potere. Jean-Jacques Rousseau ha detto già tutto ciò che occorreva dire usando parole che oggi risultano profetiche: l’allievo deve essere come cera nelle mani dell’educatore ma non deve accorgersene, il maestro deve nascondergli questo suo stato di dipendenza assoluta, l’allievo deve credersi libero di scegliere tutto ciò che il maestro sceglie per lui, allora scrive Rousseau “Il n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté”, non c’è più perfetto asservimento di quello che conserva l’apparenza dela libertà. Queste righe le scriveva il filosofo di Ginevra nel 1762, da allora abbiamo conosciuto la propaganda politica, la manipolazione delle masse tramite l’ideologia, il bombardamento mediatico, ecc. Nonostante questo c’è gente che prende le parole di Rousseau come espressione di un compito positivo. Per esempio, lo psicologo americano Skinner nel suo saggio programmatico del 1971 “Al di là della libertà e della dignità” cita la frase di Rousseau esplicitamente e dice: eih gente, così dobbiamo fare! Seconda osservazione, la Chiesa ha una particolarità o il cristianesimo ha una particolarità, la morale che predica non è una morale cristiana, una tale morale non esiste, non c’è una morale con un epiteto, neppure una morale laica, c’è la morale punto e basta. La cosiddetta morale cristiana è una morale universale, le altre religioni ci dicono come dobbiamo lavarci, nutrirci, vestirci, dove dobbiamo andare in pellegrinaggio, eccetera eccetera. Il cristianesimo non ha altre regole di vita che quelle razionali che valgono per tutti e che conoscevano già i filosofi e i saggi, il resto lo lascia all’intelligenza umana, all’intelligenza che può scegliere le vie più comode e le vie intelligenti di ottenere il bene. Sarebbe bene riproporre questa dimensione fondamentale del cristianesimo, quella della confiance fatta alla libertà umana, il cristianesimo dell’apertura infinita del campo del possibile, il cristianesimo di fiducia nella fantasia, il cristianesimo di Francesco d’Assisi, di Thomas More, un santo umorista, di Filippo Neri, dei grandi architetti del barocco, di Antonio Gaudì, di Claudel, di Chesterton, di tanti altri.
COSTANTINO ESPOSITO:
Ancora una volta è difficile intervenire dopo la cristallina descrizione di Monsieur Brague, ma non mi sottraggo. Vorrei dire che per me il punto è che oggi la libertà è in deficit di conoscenza e mi spiego. E’ come se si teorizzasse sempre di più che la libertà debba essere esercitata o non esercitata in maniera neutra, cioè la pretesa è quella di concepire la libertà senza aver bisogno di conoscere il soggetto della libertà e senza aver bisogno di conoscere l’oggetto adeguato della libertà cioè un esercizio senza soggetto e senza oggetto, non importa chi sia libero né che cosa ci fa liberi ma solo una libertà senza condizioni se non quelle stabilite dalla legge civile e penale. Una libertà senza soggetto è però una contraddizione in termini, come un volere senza che ci sia nessuno che voglia, un desiderare senza che ci sia nessun desiderante, un tendere senza un volto che tende. A me sembra che la situazione sia proprio quella per cui il soggetto del desiderio cioè l’io concreto di ciascuno di noi, il soggetto del desiderio e cioè il motore della libertà, pensate cosa significa una libertà senza uno che sia libero e che abbia coscienza di quello che vuole e di chi è lui, ecco mi sembra che oggi si affermi una libertà senza quella coscienza, per cui è come una medietà senza protagonisti individuali, è come se il rapporto si fosse rovesciato e la libertà non appartenesse a me cioè non fosse più il mio rischio, il rischio di un io ma al contrario il mio io, il soggetto, è il prodotto di una libertà impersonale, cioè, io chi sono? sono semplicemente una possibilità di farmi come voglio, una possibilità di agire, di desiderare, di tendere in maniera sganciata da qualsiasi condizione reale e il mio diritto di essere quello che voglio, questa sarebbe una libertà anonima, non io che voglio qualcosa ma io sono il prodotto della possibilità di costruirmi da me. E’ questo diritto e, ad essere più precisi, sono i diritti che producono la persona non viceversa. Non sono più i diritti a dipendere dalla persona ma la persona viene prodotta dal fatto che qualcuno, la legge, gli riconosca certi diritti. Prima di questo riconoscimento, è come se non esistesse. Questa paradossale mancanza del soggetto della libertà porta come esito anche politico ad una sindacalizzazione dei diritti cioè la possibilità tendenzialmente assoluta a fare quello che si vuole, o meglio, a costruire se stessi secondo la sola misura del proprio volere, ma questo vuol dire paradossalmente che la nostra libertà allora coincide con i diritti stabiliti dalla legge, come il caso dell’eutanasia, il dibattito per esempio attesta. Quindi, paradossalmente la suprema enfatizzazione dell’autodeterminazione, cioè il fatto che io devo decidere chi sono, e devo avere il riconoscimento di questa mia facoltà viene a portare ad un ribaltamento della questione e a far dipendere quindi il mio io, il mio volto da ciò che la legge mi riconosce e mi permette essere. La chiesa, di fronte a questo la chiesa troppo spesso, secondo me, è stata ridotta ad una agenzia di senso morale ad una, in una società che ricerca collanti etici, valori comuni, ma così la chiesa diciamoci la verità non è interessante. Quando la chiesa è veramente interessante è quando dice, e ci sono casi in è l’unica a dirlo nei confronti di tutte le altre agenzie di significato, che un io è libero solo quando è certo di una paternità, cioè solo quando si riconosce come figlio, che non è una frase retorica ma c’è solo quando si riconosce voluto ed amato per se stesso. Sarebbe un’ illusione pensare che la chiesa possa ridiventare centrale, nella nostra società, per il supporto da dare ai valori civili, sarebbe un cristianesimo senza Cristo. La sua forza contro il potere, sono d’accordo con Monsieur Brague, è troppo inflazionato questa parola potere, ma al tempo stesso il potere stesso è sempre più installato in noi nel meccanismo del nostro desiderio individuale. È comunque la forza della chiesa contro questa tendenza sta nell’affermare che il punto archimedeo della realtà intera è l’io! Cioè la realtà più indifesa ma, al tempo stesso, anche la più imponente e la più importante perché è il punto in cui si afferma il significato. In altri termini, e chiudo, senza l’io, mi sembra che questo sia la proposta interessante della chiesa, cioè che senza l’io di ciascuno di noi, senza il nostro personale riconoscimento e la nostra libertà il mondo non sarebbe la stessa cosa. Io non sono spettatore, anzi, è come se la realtà mi attendesse per diventare se stessa. E questo non per modo di dire, il potere, di cui parlava Pisolini, cercherà sempre di far risultare, tendenzialmente, non decisivo, cioè superfluo o inutile il mio io, cioè la mia ricerca del significato ultimo, e ho finito, che può essere solo mia. Nessuno può sostituirsi a me in questo a meno che lo concede assumendo uno dei ruoli stabiliti nel gioco del potere, foss’anche, anche il ruolo di colui che rifiuta l’ordine costituito dalla tradizione.
GIOVANNI MADDALENA:
Penultima domanda. Dopo la libertà, l’etica. L’etica viene invocata da tutti come la panacea di tutti i mali, la grande soluzione così della crisi economica come della convivenza tra culture diverse e non si può far finta che il problema non sia serio, ma effettivamente la soluzione è l’etica o ci sono alternative?
COSTANTINO ESPOSITO:
Ma a mio modo di vedere, lo dico brachilogicamente, l’etica non è la soluzione ma è una condizione, una condizione necessaria ma non sufficiente per la soluzione del problema umano. E se le due cose si confondono, l’condizione e soluzione, l’etica diventa inevitabilmente moralismo. Cosa intendo dire usando il termine “la soluzione del problema umano”? la soluzione è il compimento dell’io vale a dire, gia in senso aristotelico e, poi, cristiano vale a dire il fatto che nulla dell’io vada perso ma tutto sia abbracciato anche la contraddizione, l’incoerenza e il male. E non in senso escatologico alla fine dei tempi ma come giudizio presente. Per questo mi sembra che la soluzione non è la coerenza, è la irreprensibilità. Per altro esistenzialmente assai difficile ma, la soluzione non è che noi riusciamo a non fare più il male ma, che anche il nostro male, il nostro errore possa essere un gradino, un passo nel cammino, un’occasione per riannodare il rapporto che ci fa essere, vale a dire il rapporto con l’essere stesso il mio innanzitutto quello degli altri, del mondo intero, come una donazione, come una gratuità. Anch’io scelgo una parola che per me è decisiva, tutto sta nell’accento con cui pronunciamo la parola gratuità, a mio modo di vedere la più importante per una morale non tutta risolta in etica. Nella nostra lingua il gratuito può sembrare cioè che è senza ragione, assurdo, immotivato ma può significare anche ciò che ci è dato gratis, per grazia, cioè per una donazione amorosa, anche semplicemente a livello naturale. Il punto infuocato, in cui secondo me, tutta l’etica sta o cade è se essa permette di scorgere questa gratuità al cuore della legge o se pensa, la legge, come alternativa alla gratuità. Voglio subito precisare: non mi interessa riproporre il dualismo tra il sentimento della vita come dono e la conoscenza dura come misura, no. O il dono è dentro la misura oppure non c’è. O il dono si rende presente, anzi, operativo, come criterio di giustificazione della norma morale oppure è un appello vuoto, fastidioso che non cambia niente alla nostra moralità. Per questo la morale inerisce essenzialmente alla dinamica del conoscere, e torniamo al tema del meeting cioè, il dono non è un auto-convincimento, un emozione, o un’ illusione sentimentale con cui reggere la durezza della vita, o by-passare le ingiustizie, ma è una vera e propria logica del rapporto. Lo ha ricordato in maniera eccezionale Benedetto XVI nell’enciclica “charitas et veritatis” e questo a partire da quel rapporto determinante tutti gli altri che è il rapporto a me stesso. Cioè, o il dono lo si capisce nel mio rapporto a me stesso o non lo si capisce. E in che senso è problema di conoscenza? Perché tutto dipende da come ci conosciamo, se io sono dato a me stesso o sono il prodotto delle mie capacità. Nel primo caso io riconosco in me qualcosa di oggettivo cui devo dare spazio, un volto, una dignità irriducibile, anche alla riuscita o non riuscita delle mia performances; nel secondo caso, l’io come prodotto, io sono l’esito del meccanismo biologico naturale o del sistema culturale e la mia individualità resta irrazionale, immotivata, ultimamente vaga, inutile. Per questo, come ultima battuta, vorrei dire che secondo me sarebbe veramente interessante poter ripensare il nesso tra la morale e la soddisfazione cioè concepire un’etica non contro il desiderio dell’io ma un un’etica del desiderio a patto, s’intende, di non bloccare la dinamica del desiderare ma d’intenderla come seguire l’attrattiva del reale e trovare in questa attrattiva la vera universalità del legge morale.
RÉMI BRAGUE:
Anch’io sono sensibile all’inflazione dell’invocazione all’etica e irrita anche me. E vorrei fare tre osservazioni, due brevissime e una più lunga. L’etica è divenuta in modo di schivare i problemi tecnici o politici, è più facile predicare una condotta etica per risolvere i problemi economici o culturali. Utilizzare l’etica come panacea è il sintomo di un atteggiamento fazioso, la pigrizia. Chi dovrebbe comportarsi eticamente non è mai colui che predica la morale, è sempre l’altro. Un solo esempio, un esempio francese: il problema della violenza nei sobborghi parigini viene spesso risolto con l’invocazione alla tolleranza, cosa vuol dire? I ricchi e i potenti, quelli che vivono in quartieri protetti, le cui macchine sono parcheggiate in rimesse sotterranee dicono ai poveri e ai deboli, cui le macchine sono state bruciate che devono essere gentili con coloro che sono ancora più poveri e deboli di loro e che hanno bruciato le loro macchine. Queste due prime mostrano il carattere immorale di qualche invocazione all’etica. La terza è di una portata maggiore allora, questa sopravalutazione dell’etica è un fenomeno storico che risale a parecchi secoli, molti dicono: basta un’etica credibile e dei poliziotti che facciano bene il loro mestiere. Se abbiano questo non abbiamo bisogno di una metafisica e ancor meno di una metafisica per il popolo cioè di una religione. Si pensa così a partire dall’illuminismo ma, tutto dipende da quello che vogliamo fare quando si fa la domanda di cosa abbiamo bisogno? Tutto, noi capiamo, bisogno per fare che? Allora la tesi dell’illuminismo è vera fino ad un certo punto, affermando che noi non abbiamo bisogno di una metafisica ci sic riferisce ad un noi come viventi e che dobbiamo vivere insieme. La società che è la somma di tutti gli essere umani presenti in un paese dell’umanità, che è quella di tutti gli uomini, possiedono in se stesse tutto l’occorrente per arrangiarsi, in via di principio. Basta adoperare la ragione nel senso più elementare della parola latina “ratio” calcolo in questo caso il calcolo dei vantaggi. E, allora, sarà ben chiaro che dobbiamo preferire una società in cui non si ammazza la gente, non ci si deruba a vicenda della roba o della moglie, eccetera. Tutto questo basta per fare qualcosa, tutto questo basta per vivere. Perché viviamo noi. Ma non basta per fare vivere altri, non basta per rispondere alla domanda più radicale, sulla legittimità dell’umano perché è meglio che vi siano uomini sulla terra. Come si più giustificare alla vita uomini che per definizione sono altri e che no possono dirci, se vogliono venire al mondo. Allora, io sosterrei la tesi opposta a quella illuministica: le società occidentali soffrono non di una mancanza di etica ma, piuttosto, di una mancanza di metafisica.
GIOVANNI MADDALENA:
Ultima domanda, perché il tempo stringe, ed esattamente a proposito di metafisica, sui temi che abbiamo trattato, sulla filosofia. La filosofia non ha sempre goduto, e non sempre gode, di buona fama, a volte giustamente. La domanda che cosa fa un filosofo, su che cosa fa ricerca, che cosa scopre, quali sono i suoi strumenti è ampiamente ripetuta. Quali sono i temi urgenti che la filosofia deve affrontare e quali sono i suoi strumenti? Monsieur Brague.
RÉMI BRAGUE:
La risposta molto parziale. La filosofia deve accettare quelle critiche che sono così vecchie come essa stessa. La filosofia deve resistere alle tentazioni di spacciarsi per una scienza, per esempio nell’uso dei simboli logici dove non sono necessari. Per tutti i problemi normali ci sono gli specialisti, per i problemi ai denti c’è il dentista, per problemi con la macchina c’è il meccanico, per problemi con il sifone c’è l’idraulico eccetera ma, ci sono anche problemi che toccano a tutti perché toccano tutto, e per questo non ci sono specialisti. Il filosofo è lo specialista delle domande per le quali non ci sono specialisti, queste domande, queste domande le possono fare tutti le fanno tutti e in linea di principio le potrebbero risolvere tutti. Il filosofo non è un uomo eccezionale è piuttosto quello che accetta di non essere eccezionale, di affrontare le questioni di tutti. La materia prima della filosofia è fatta di disposizioni affettive, non so bene come si chiamano in italiano ma non sarebbe meno difficile dirlo stesso in francese, se facessi questa relazione in tedesco adopererei la parola stemonk (?) che non si traduce facilmente, si chiamano stimonen l’angoscia, la noia, l’inquietudine, l’ammirazione, la gioia eccetera. Non si potrebbe fare filosofia senza queste disposizioni. Perché? Perché tali disposizioni ci danno adito a tutto quello che c’è e al tempo stesso al mistero della nostra presenza del mondo. Quando sono gioioso dico che tutto va bene, tutto va bene. Una parola molto profonda e ben chiaro che non voglio dire nelle stelle più lontane, OK. Tutto, la totalità della mia presenza del mondo mi appare in una luce positiva. Lo stesso si potrebbe dire della noia, eccetera. Se non ci fossero stimonen, non ci sarebbe filosofia. Gli uomini si accontenterebbero del sapere empirico o scientifico delle cose. E allora la ragione nella filosofia, la ragione è utilissima ma è soltanto uno strumento per chiarire le domande che vengono dalle stimonen. La filosofia aggiunge un po’ di chiarezza e per questo non è l’intelligenza la qualità maggiore del filosofo, è chiaro che sarebbe meglio essere intelligenti ma lo stesso si può dire di tutti i campi dell’azione umana. Un dentista intelligente è meglio di un dentista stupido, no? La qualità principale del filosofo è la capacità di vivere nell’angoscia e di convertirla in esigenza di chiarezza. Non ci si deve aspettare più di quella che essa propone, voglio dire un po’ di chiarezza. Ma neppure la filosofia deve fare promesse che non può adempiere, tutte le volte che lo fa si espone a deludere la gente. La filosofia non ha una salvezza da proporre. Da qualche anno è stato osservato che dagli antichi greci e romani la filosofia era prima di tutto un modo di vivere e solo secondariamente un sapere. Questo lo ha detto, per esempio, un grande studioso francese Pierre Adou. Può darsi che si è esagerato un po’, ma in fondo è vero. Ma, oggi, ci sono autori che propongono metodi per essere felici, può darsi che sia ridicolo ma va bene. C’è ancora di peggio, c’è anche gente che presenta questi metodi, per essere felici, come filosofia, la filosofia sarebbe una specie di quello che gli americani chiamano self-help, tutto questo mi pare una truffa. La filosofia non ha ne la facoltà ne il diritto di promettere la salvezza. Perché? Perché non ne ha i mezzi, nemmeno l’etica può farlo. Hegel dice, il filosofo tedesco Hegel, dice che quando si soffre di cattiva digestione non c’è verso di curarsi studiando la chimica. Io direi di più, specialmente all’etica è vietato promettere la salvezza. Questo l’ha detto, molto chiaramente, Kant. Kant diceva che la moralità, la condotta morale soltanto perché in cui si fa il bene, perché il bene e soltanto perché il bene, la moralità non può garantire la felicità. L’unica cosa che essa riesce ad ottenere è far si che l’uomo diventi degno della felicità. Ma la felicità non la può produrre.
COSTANTINO ESPOSITO:
Vado velocissimamente. Per quanto riguarda la filosofia, anche a me ha sempre colpito il fatto che la filosofia, anche a me ha sempre colpito il fatto che la filosofia può essere e sia stata di fatto una possibilità formidabile di comprendere quello che c’è. Ma anche una delle più clamorose possibilità di misconoscere, ridurre o a volte negare i dati di fatto e quindi vorrei dire che, secondo la mia sensibilità non pretendo di dire quello di cui si dovrebbe occupare la filosofia oggi, non mi permetterei mai, ma per quello che avverto come un’urgenza per me, ma non del tutto soggettiva, mi sembra anche rispondente a delle tendenze obiettivamente, presenti nel nostro mondo. Io direi che il grande problema, io l o direi così, è come se fosse un gap, un punto irrisolto nella coscienza filosofica del nostro tempo, e cioè, una divisione fatale, l’affermazione da un lato dell’io senza verità e dall’altro l’affermazione della verità senza l’io. I cui estremi, per dirla alla buona, sono un estremo relativismo e il fondamentalismo. (?) a me sembra che sia particolarmente interessante la vera posta in gioco e, che questi due fattori, stanno e cadono insieme. Cioè è ricapire che non possibile conoscere l’io senza questa apertura al vero ma, che anche il vero mi si da, come dicevo prima, toccandomi, interpellandomi, chiedendo di me. Allora con due battute finali direi così: che secondo me la grande posta in gioco, oggi, della filosofia è una educazione della razionalità e una educazione alla razionalità. E mi spiego: educare la ragione, educazione della razionalità vuol dire riaprire la traiettoria delle domande della nostra conoscenza. Cioè comprendere sempre di più, e non è mai scontato, che la ragione non è una funzione astratta della nostra mente ma è una vita, cioè è la storia del nostro incontro con altro da noi stessi. Per questo la dinamica della ragione, cioè la serie delle sue domande è infinita. È un dinamica che non si può mai bloccare, intenderei questo come educare la razionalità, cioè scoprire la portata infinita mai conclusa del suo tentativo di penetrare l’essere. Ma la chiamerei anche un’educazione alla razionalità, intendendo per razionalità in questo secondo caso, non solo la nostra facoltà ma il senso del mondo. Il fatto che il mondo abbia una ragione, il fatto che il mondo abbia una ragione. E questo senso del mondo nessuna filosofia, e mi permetterei di dire neanche nessuna religione, ce lo può dire a priori una volta per tutte. Perciò l’educazione alla razionalità è come capire che la nostra facoltà razionale diventerebbe rattrappita, si seccherebbe se non riscoprisse ogni volta un senso o un ipotesi di senso presente, e non la strappasse per così dire, questo mistero dalla realtà stessa. Allora, insieme, un’educazione della ragione e un’educazione alla ragione, al logos, al senso. La mia facoltà senza il senso sarebbe un meccanismo, ma il senso ha bisogno della mia facoltà per emergere nell’evidenza, nell’esperienza e quindi accorgersi che la ragione no è, solo, un domandare infinito ma anche un domandare dell’infinito.
GIOVANNI MADDALENA:
Ringrazio a nome di tutti i nostri ospiti, il prof. Esposito e il prof. Brague e ringrazio tutti voi per il lavoro svolto, sperando che uno abbia capito che intelligibilità delle cose può essere un’avventura affascinante, interessante e persino divertente.
(Trascrizione non rivista dai relatori)