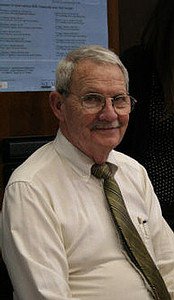Chi siamo
L’ARTE COME AVVENTURA DELLA CONOSCENZA
Partecipano: Beatrice Buscaroli, Storica e critica d’arte, co-curatore Padiglione Italia 53a Biennale di Venezia 2009; Francesco Casetti, Docente all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano; Robert Hollander, Docente Emerito di Letteratura Europea a Princeton. Introduce Davide Rondoni, Poeta e Scrittore.
DAVIDE RONDONI:
Il Meeting dedica un incontro all’arte, all’interno del tema generale di questa settimana. Proviamo a domandarci in che modo l’esperienza dell’arte si può considerare parte non secondaria dell’avventura della conoscenza che segna il cammino dell’essere umano. Troppe volte, l’esperienza che si dà al nome di arte ha qualche cosa che invece sembra essere fuori da questa avventura della conoscenza, come se il momento dell’arte fosse un momento piuttosto dell’evasione dall’avventura della conoscenza, o anche, più banalmente, il momento dell’intrattenimento, che non c’entra con il resto della vita, il momento in cui non si acquisisce qualcosa di importante sull’esistenza ma ci si distrae con qualcos’altro. Nell’educazione della gente che fa il Meeting, invece, l’incontro con l’arte, nelle sue varie forme, è sempre stato il momento primario dell’educazione all’incontro con la conoscenza del reale. Cito l’episodio che molti di voi conoscono, di quando don Giussani stesso racconta che, addirittura per conoscere meglio quello che stava facendo mentre andava a fare la comunione, da giovane seminarista, per conoscere meglio quella cosa che stava facendo, diceva tra sé e sé i versi di Leopardi, perché avere in mente i versi di Leopardi, mentre si accostava al corpo e al sangue di Cristo, era un modo per conoscere meglio quello che stava facendo. In questo senso, l’arte ci è sempre stata indicata come un momento in cui si acquisisce maggior senso critico rispetto all’esperienza che si vive. Non come momento a lato dell’esperienza che si vive, ma come momento in cui la ragione e il cuore scoprono di più quello che stanno vivendo. Per verificare, per paragonarci con questa ipotesi, con questo modo di vivere l’arte, che deve fare i conti, oggi, con mille seduzioni, con mille perplessità, con mille proposte diverse, per confrontarci e parlarci di questo, sono molto contento di avere qui con noi ospiti tre grandi lettori dell’arte, tre grandi esperti dell’arte, a livello nazionale e internazionale. Il Meeting propone cose a livello nazionale ed internazionale, non solo nel campo dell’economia e della politica, ma anche nel campo dell’arte e della conoscenza umana attraverso l’arte. Il primo che parlerà – seguiranno la professoressa Buscaroli e poi il professor Casetti – è una conoscenza recente del Meeting, è stato ospite anche l’anno scorso: evidentemente si è comportato bene, l’abbiamo nuovamente invitato, ha superato la prima prova, non tutti la superano. E’ il professor Robert Hollander, che ha insegnato per quarant’anni a Princeton. E poiché la sua lunga esperienza di insegnamento si è particolarmente concentrata su una serie innumerevole di studi e di libri sulla figura di Dante all’interno della letteratura europea e italiana medioevale, gli abbiamo chiesto anche quest’anno di donarci una sua lettura di una parte di Dante, in questo modo reagendo, come lui sa fare, alla suggestione del tema del Meeting. A lei la parola, professore.
ROBERT HOLLANDER:
Grazie, Davide. Su un’epigrafe che si trova sul volantino – lo avete tutti? Spero di sì! -, potete leggere queste parole: ci sono solo due categorie di lettori che si sentono particolarmente offese per il modo in cui Dante pretende di essere l’autore ispirato di un poema sacro, i non credenti e i credenti. In ciò che segue, nella discussione sulla presenza di Catone nel Purgatorio, non si deve dimenticare che questi due canti rappresentano le prime esperienze del protagonista sotto la sua guida e di noi lettori dell’Anno Santo. Il Purgatorio è totalmente sotto la balia, non solo di Catone, ma di Dio. Con l’introduzione, sul depliant si possono trovare queste due citazioni, la prima di san Tommaso e la seconda di Dante, che si riflettono, come vedrete. In queste introduzioni, Dante, come tomista e allo stesso tempo contro, è il teologos, il poeta. Come definito da san Tommaso, questo teologos poeta è Dio stesso. Dante definisce se stesso come teologos poeta, cosa assolutamente vietata da san Tommaso. Questo è forse il soggetto dantesco più astratto, scolastico in tutti i sensi, e lo tratterò in un modo frettoloso. Coloro che sanno, tra di voi, mi scuseranno la brevità e semplicità forse imperdonabili. Più di trent’anni fa, in un articolo, ho tentato di codificare le condizioni che sostengono le seguenti posizioni interpretative. Primo: Dante ha deciso di utilizzare l’allegoria biblica per la struttura del significato della Commedia. Secondo: la ragione che lo ha convinto a fare una tale scelta, assolutamente proibita agli scrittori laici, sta in san Tommaso, il quale insistette che i poeti secolari non potevano scrivere altro che fabulae, cioè favole, materie forse verosimili, ma non di meno false, inventate. I poeti, secondo il gran teologo, erano nient’altro che bugiardi. Lo dice san Tommaso, usa esattamente questo termine. Terzo: la risposta di Dante fu di consentire a questa proposta dell’Aquinate, salvo che nel suo caso. Per questa ragione percepiamo – almeno qualcuno di noi – il suo ruolo di teologo-poeta e non poeta-teologo, l’ordine dei termini è importante.
Per Dante, il momento decisivo del Purgatorio XXIV è quando dice: “Io son uno, quando amor mi ispira, noto”. Le scoperte del Ravennate, Paolo Amaducci cominciate 100 anni fa, ma raramente ricordate dai tanti dantisti odierni e quelle di Erich Auerbach hanno cambiato l’armatura delle discussioni basilari della Divina Commedia. Siamo costretti a non entrare nel dibattito per nessun’altra ragione che la mancanza di tempo. Voglio solo dire che ciò che serve per la comprensione del poema, è capire che esso si presenta come storico, cioè come se tutto ciò che è presentato come accaduto fosse veramente accaduto. E’ per questa ragione che poi insiste tante volte, circa 400, sulla propria esperienza visiva dell’oltremondo, non inteso nel senso cesariano “Veni, vidi, vici”, ma in quello dantesco: “Vidi, vidi, vidi”. E’ ovvio che sa, Dante, che noi non siamo né disposti ad accettare, né capaci di farlo, questi fatti come veri. Per esempio, nel XVI canto dell’Inferno, il poeta ci guarda negli occhi e ci promette: “ma qui tacer nol posso; e per le note di questa comedìa, lettor, ti giuro,”. Che cosa giura? Che il fiorentino sceso nell’inferno fu realmente in compagnia di Virgilio, con quale continua il suo viaggio infernale al centro della Terra. Se credete a ciò che Dante assevera, siete pazzi. Poi la questione è: perché lo fa? Secondo punto introduttivo, la parola “conoscenza” nella Commedia. Si vede otto volte, quattro nel senso che ci interessa: nel X e XXVI capitolo dell’Inferno, nel XVII e anche nel XXVI del Paradiso. Farinata e Ulisse parlano della conoscenza di questo mondo, mentre Beatrice e Dante dell’ultima conoscenza, quella della divina lettura. Risulta che ci sono due forme di conoscenza nella Commedia, ciò che noi mortali abbiamo del nostro mondo e ciò che pochi possono vantarsi di avere, quella del regno divino. E’ interessante che la conoscenza umana di Ulisse, nel XXVI dell’Inferno, sia proposta dalla conoscenza, da parte del protagonista, dell’amore di Dio nell’altro canto numerato XXVI, giustapponendo ancora una volta, anche se per caso, Ulisse e Dante, come vedremo accade anche alla fine del primo canto del Purgatorio. Percorriamo rapidamente le prime tre scene della Cantica, i versi dall’1 al 12. I lettori si trovano nel secondo regno di Dio, dove il poeta invoca l’aiuto delle sante muse e di Calliope, musa della poesia epica. Ai versi 13-18, con la frase “dolce color”, troviamo una sorta di parola chiave, impossibile per descrivere qualsiasi oggetto o azione che si veda nell’Inferno. L’azione del Purgatorio inizia nella Terra promessa, almeno dal suo vestibolo, versi 19 – 27. Nel cielo si vedono i pesci, ma invece siamo nel segno di Cristo. Le quattro stelle sono le virtù cardinali, innate nella prima gente e solo nella prima gente, cioè in Adamo ed Eva. E poi il Catone dantesco, dissimile da Caronte, il primo guardiano infernale, nominato tre volte nel terzo canto dell’Inferno: Catone non è un dannato, anche se opera drammaticamente nei primi due canti del Purgatorio. Dalla prospettiva delle spiagge del Purgatorio, sembra che questo innominato non debba essere altri che Catone Uticense, identificato dalla storia e dal poema epico di Lucano. Di fatti non c’è stato un solo istante di un dantista che abbia negato l’identità assoluta di Catone, anche se troviamo che i commentatori insistono a trovare una valenza allegorica. Forse perché la presenza di un pagano suicida mette Dante contra imperium romanum. Ma Catone è destinato alla vita eterna nel Paradiso “Tu ‘l sai, ché non ti fu per lei amara in Utica la morte, ove lasciasti la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara”. Non si può argomentare che, secondo Dante, Catone è salvato. Ma il più pressante problema è semplicemente questo, che nessuno sistemicus letteratus o teologo abbia mai detto o forse anche pensato che Catone fosse cristiano. Come mai Dante insiste che lo fu? E’ lo scandalo che ha agitato i dantisti fino ad oggi. Come dobbiamo comprendere che Dante abbia concepito il suo Catone cristiano, un santo Catone? Il figlio del poeta, Pietro, fu forse il primo e, per un lungo periodo, il solo che insistette che Cristo avesse liberato Catone dal Limbo, salvandolo con una decisione straordinaria. Non di meno, anche Pietro tentò di rafforzare l’effetto della sua propria decisione allegorizzando Catone con l’onestà, ma non esiste dubbio che dobbiamo concepire il Catone dantesco come personaggio storico, cosa poi necessaria in considerazione delle ragioni che produssero la sua decisione di trattarlo così. Ma quando si leggono i commentatori trecenteschi e altri più recenti, ci si trova confortati da astrazioni, per esempio santità di vita, libertà, ma sono virtù inventate, perché l’interprete deve pensare a un cattolico cristiano e magari a un cristiano salvato. Ci sono altri otto passi dei primi due canti, ma mi riferisco a due. Il primo, Catone è presentato come padre, una figura di autorità nei versi 65-66. E’ Virgilio che ci informa che Catone sorveglia sugli spiriti che “purgan sé sotto la tua balìa”. Cioè, Catone viene incaricato di dirvi “governo tutto il mondo del Purgatorio”, non solo la spiaggia davanti il Purgatorio. Ovviamente non deve intervenire di solito, perché gli spiriti sono mossi solo da amore divino, non c’è nel poema neanche l’ombra di un piccolo peccato commesso nei confini di questo reame, mentre saremmo testimoni di un evento peccaminoso nel secondo caso.
Secondo, la barba di Catone cadeva sul petto in doppia lista. Mosè, nell’iconografia medioevale, portava la barba allo stesso modo, e fino a San Tommaso è presentato con quella barba a doppia lista e anche nel Mosè di Michelangelo. Ma c’è una fonte virgiliana nel Catone dantesco: Eneide, libro VIII verso 670 – e anche questo voi avete sul depliant -. Questo è lo scudo di Enea, l’oggetto forse più importante per la romanitas, come presentato nell’Eneide. Catone appare molto più spesso in Virgilio, ma quando è stato incluso, che cosa ha visto Dante? Ha visto il suo nome, Dante, associato con il nome di Catone. Tutto questo trovate nel testo di Giuliano, Dante e Catone come vicini di casa, una cosa straordinaria che, io sono sicuro, non posso provarla, ma io sono sicuro che Dante abbia notato, sarebbe stata una sciagura se non l’avesse fatto. E poi nelle parole di Virgilio, il secondo passo: “O ti piace gradire la sua venuta, libertà va cercando ch’è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta – Gesù Cristo che ha rifiutato la vita per salvarci – tu lo sai che non ti fu per lei amara, in Utica la morte ove lasciasti la veste che al gran dì sarà sì chiara”. Impossibile argomentare che Dante non voglia che noi capiamo che Catone sarà salvato. E’ Virgilio, che ci offre la prima occhiata di Catone-Mosè come tipus Christi, che ha liberato i pagani credenti, includendo Catone, dal Limbo. Terzo, lo sbaglio di Virgilio nel tentativo di lusingare Catone, mutando la captatio benevolentiae praticata da Beatrice su di lui, quando lei era arrivata al Limbo nel secondo canto dell’Inferno, come capì immediatamente Catone. Sarà lui a caratterizzare questi versi di Virgilio come lusinghe, al verso 22. I commentatori, fino all’Ottocento, hanno capito che Catone non reagisce pacatamente alla richiesta di Virgilio, ma poi si iniziò una lettura positiva del verso, forse con Bianchi, nell’Ottocento. Dice Bianchi: “qui in senso onesto, le lusinghe valgono blandimento, preghiere con dolce lode”. Ma non è vero, nelle perdute genti è meglio implorare il nome della cristiana Beatrice.
Il terzo passo: il giunco, come la corda francescana, è cosa umile, di poco valore, ma che simboleggia l’umiltà, non la forza contro le persone, rappresentata invece dalla cintura, dalla corda, la quale portava il protagonista utilizzato da Virgilio per dare la sfida a Gerione.
Il quarto passo. In questo pagina, il battesimo – per così dire – di Dante, dissimula Ulisse, il quale l’abbiamo incontrato nel XXVI canto, e che nella sua superbia morì a poca distanza dal sito di questo loco umile, locus umilis. Dante si è associato con Virgilio in quella virtù morale, l’umiltà. Secondo me almeno, Dante è presentato come un anti- Ulisse, viaggiatore in bono.
Salto qualche passo del secondo canto, per arrivare al terzo, sulla pagina accanto, il passo di Casella. Abbiamo ascoltato un salmo dell’Esodo, salmo 133, che rappresenta il commento di Dante all’arrivo dei purganti nel Purgatorio. Ora abbiamo un’altra canzone, questa scritta da Dante stesso, “Amor che nella mente mi ragiona”, che è contenuta nel Convivio e che ora è cantata da tutti i presenti, salvo Catone. Catone ci ha lasciato perché ha detto a Dante, alla fine del primo canto, di non aspettar di vedere tanto di più.
Il centro della controversia che continua ai nostri giorni attorno a questo canto è che, in Purgatorio, non si cantano cose vane e lascive, ma inni e salmi e lodi di Dio. Invece i salvati, sotto l’influenza maligna di Dante Alighieri, non stanno facendo questo. La maggioranza dei commentatori sostengono che non c’è niente di male nella richiesta di Dante né nella acquiescenza di Casella.
Ma che cosa dobbiamo capire dopo l’intervento di Catone? E ora concludo.
Catone mi appare nel modo di Mosè in Esodo, capitolo 30, quando uscì dal monte con le leggi che rifiuta di dare agli ebrei. Gli ebrei sono per Mosè esattamente come i cristiani per Dante, stanno agendo in modo improprio. Non c’è uno che Mosè ascolti quando lui vede che cantano agli dei.
“Lo scoglio che non lascia a voi, Dio manifesto”. Questo è il problema di Dante. La prima cosa che lui fa, in Purgatorio, è di essere come se non meritasse di essere in Purgatorio. Ma questo sarà un problema per lui fino alla fine del Purgatorio, quando nel dialogo con Beatrice trova una via giusta, la via che ha preso senza comprensione. E’ stata la grazia che ha salvato Dante, che non meritava di essere salvato. Questo è il dramma umano che troviamo nella Commedia. Con queste parole finisco questo intervento. Grazie per l’ascolto.
DAVIDE RONDONI:
Grazie, prof. Hollander, anche per l’esattezza “micidiale”, mi verrebbe da dire, della sua lettura, per come ha affrontato lo scandalo di questa presenza di Catone tra i salvati. La ringrazio anche per la fatica del viaggio che ha fatto per essere con noi in questi giorni e per la gentilezza di avere parlato italiano, in modo che potessimo seguire e anche gustare il suo accento. Adesso, dalle parole ricche e movimentate della Commedia di Dante, passeremo a parlare di arte, in particolare di arte contemporanea, e poi parleremo di cinema. Di arte abbiamo chiamato quest’anno a parlarci – ma ha superato vari esami, è già qui per la terza volta con noi – Beatrice Buscaroli, che tra l’altro, oltre a insegnare all’università di Bologna, nella sede di Ravenna, e avere molte pubblicazioni e incarichi prestigiosi, è di fresca esperienza per aver passato una delle cose più prestigiose e pericolose che possano capitare ad uno storico dell’arte o a un critico d’arte, che è quello di aver selezionato i pittori italiani, insieme a un altro critico, per la Biennale di Venezia che è in corso quest’anno al Padiglione Italia. Tra l’altro, vi invito a vederla, se volete avere un’idea dell’arte contemporanea. E’ uscito anche un suo libro, di recente, dell’editore Marietti, che vi consiglio di leggere se siete appassionati all’arte di tutti i tempi, perché è un modo di raccontare le figure dei pittori davvero convincente. E’ un libro che si chiama I colori nelle mani. Qui a Rimini si sta svolgendo una grande mostra di arte contemporanea, alla Rocca Malatestiana, dal titolo Contemplazioni, di cui Beatrice è una sorta di ispiratrice. E’ curata da un giovane critico che si chiama Alberto Guazzani, ma Beatrice è quella che ha dato un po’ l’impronta di partenza. In questi giorni, approfittate, se amate l’arte contemporanea, per vedere questa grande esposizione. A lei abbiamo chiesto di misurarsi con questo tema, sul terreno dell’arte contemporanea che, come sappiamo tutti, molte volte è quello più attraversato da inquietudini e da una sorta di sconforto, come se l’incontro con l’arte contemporanea ci facesse accedere, piuttosto che a una conoscenza, a una sorta di dubitosità che si arresta di fronte alle opere. Lei nelle opere sta viaggiando da tempo, chiediamo di fare un passo insieme a lei.
BEATRICE BUSCAROLI:
Ringrazio tutti, in particolare gli organizzatori del Meeting, che mi hanno dato anche quest’anno la possibilità di venire a confrontarmi con una platea, che – devo dire – ogni volta non cessa di stupirmi, perché mi faceva piacere condividere con voi, e con chi ha seguito questa mia serie di interventi, in un certo senso a puntate, la vicenda di quest’anno, la storia della “Biennale”.
Rispondere a un argomento come “l’arte come conoscenza” è troppo arduo per una sola conferenza, quindi andrò leggermente fuori tema, perché direi che il mio potrebbe essere più facilmente chiamarsi “arte come avventura”. Se mi venisse chiesto se l’arte è avventura della conoscenza, in questo momento, avrei seri dubbi.
Quindi lancerò alcuni temi, alcune piccole provocazioni, che sono più che altro motivi di una riflessione che io sto conducendo da diversi anni. E’ stato interessante; è una opportunità unica nella vita, quella di confrontarsi proprio con un agone, così difficoltoso e universale quale è la “Biennale di Venezia”. Questa esperienza ha segnato anche il mio rapporto con la domanda su l’arte come conoscenza.
Faccio una premessa, poi entro nel vivo del mio intervento. Col collega Luca Beatrice, abbiamo scelto venti artisti italiani. Di questi, nove sono pittori e uno è scultore. Uno è anche un disegnatore, che in questo caso ha lavorato col video.
Abbiamo scelto undici artisti che lavorano con le cosiddette tecniche tradizionali.
Nei confronti del nostro padiglione, il Padiglione Italia, ogni giornale ha preso delle posizioni molto forti dal punto di vista critico. In principio questi interventi ci facevano preoccupare, alla fine ci facevano sorridere, perché abbiamo constatato come nel nostro paese la critica d’arte e soprattutto la critica d’arte giornalistica sia diventata faziosa, ma soprattutto sia diventata cieca.
Questo è l’argomento che mi interessava affrontare oggi. Noi abbiamo una vita dell’arte e una realtà che esiste, è presente, abbiamo dei pittori che hanno dai ventiquattro agli ottanta anni e la cosa che a noi fa soffrire, a noi, alle persone che ancora credono nella tecnica, nella bravura, nella espressione e nella verità dell’arte, a noi dispiace il fatto che questo sia ufficialmente negato: la nostra scelta di portare undici artisti di tecnica tradizionale su venti, ha portato a uno sconcerto quasi mondiale, che è uscito anche dai confini. Il giornale “Le Monde” parlava della “pittura catastrofica” (peinture catastophique) degli italiani, proprio perché loro hanno bandito e sono ancora più di noi vittime di un pensiero ideologizzato, ma che ormai vive come una sorta di mongolfiera impazzita, in una sua assoluta autonomia.
Mentre una realtà dell’arte, che è quella che voi potete constatare se andate a visitare la Biennale Arti Visive, vive ancora all’interno di questo divieto di praticare l’arte in sé, ci vien fatto credere che l’arte sopravvive soltanto come denuncia sociale, come problema, oppure come non-arte. Quel che a me, come a pochi altri critici d’arte italiani interessa è dimostrare che esiste anche una teoria critica che va al contrario di quello che sta succedendo. Il fatto è che l’arte esiste. Soltanto da questo punto di vista e anche da questa speranza potrà ricominciare nel nostro paese come ha ricominciato in altri paesi un nuovo stimolo a vedere, guardare, constatare ciò che esiste, che c’è. Ora, se a tutti gli eccessi è seguito nel tempo un periodo di assestamento, ricordo che alla fine del settecento vi fu un momento in cui per opporsi agli eccessi decorativi, agli eccessi di gusto, agli eccessi anche di rappresentazione, di forma di virtuosismo di bravura del Barocco, ci fu una corrente di pittori francesi che, esasperando certe tensioni del Neoclassicismo (si chiamavano Primitives) arrivarono a dipingere soltanto con un lievissimo segno di contorno, ossia eliminando tutto ciò che nel tempo e nella tradizione erano state le grandi conquiste della pittura, come la prospettiva, il rilievo, il colore, la terza dimensione, l’architettura dipinta. Questi artisti sono, dal punto di vista del pensiero, molto interessanti, perché la tendenza alla purezza che li contraddistingue li fece giungere ad annullare quasi il gesto del dipingere, come se fosse una contaminazione con qualche cosa che era necessariamente impuro rispetto all’idea che se ne aveva. E’ una sorta di radicale neoplatonismo che trova anche la rappresentazione degli dei una cosa impura. Come scrive Robert Rosenblum, che è uno storico dell’arte molto importante, autore di questo testo fondamentale, Trasformazioni nell’arte, l’ aspirazione all’ azzeramento dei valori, l’idea di partire da una sorta di tabula rasa, è proprio un segno ricorrente dei tempi. Infatti, scrive Rosenblum, certe analogie tra l’arte del 1800 e quella del nostro tempo non sono sorprendenti. Questa idea della tabula rasa ha lasciato moltissime influenze, una eredità di sogni ostinati e irrealizzabili, che non ha mai cessato di ossessionare e nutrire l’immaginazione degli artisti all’opera nel mondo moderno. Dopo cent’anni – siamo al principio del novecento – c’è realmente un ritorno a questo azzeramento, questa volta fatto con molta maggiore brutalità, con molta maggiore forza, con un urlo molto più forte rispetto al gesto umile e discreto dei Primitives che cessano di dipingere.
E’ la seconda volta che si azzera il passato, come tradizione, come realtà, così come avviene con le avanguardie primo-novecentesche. Attraverso le avanguardie, indipendentemente da dove si parta, dall’espressionismo tedesco, dal futurismo italiano, dal surrealismo, dal dada, gran parte delle avanguardie proclamarono la necessità di rompere con il passato e dichiararono quasi inevitabile la rottura con la pittura in senso tradizionale, la scultura in senso tradizionale, l’architettura con aspirazione estetica, fino a rinunciare alla rappresentazione e al significato in arte.
Quello che a me ancora stupisce, e che fu oggetto di uno dei miei primi interventi qui al Meeting, è come noi ancora, dopo cento anni, siamo rimasti vittime di questa chiusura. Io vi citerò adesso tre filosofi e teorici dell’arte, che a distanza di decine di anni, scuole distanti per cultura e per origini, dicono tutti esattamente le stesse cose, si pongono gli stessi pensieri, gli stessi problemi che ci poniamo noi.
Hans Sedlmayr è un professore della scuola di Vienna, nato nel 1896, allievo della grande scuola di Vienna cosiddetta puro-visibilista, seguace di Dvorak, di Julius von Schlosser, che scrisse alcuni tra i primi libri fondamentali sul problema delle arti nel nostro secolo, La perdita del centro, che interpreta la perdita di questo equilibrio e la rivoluzione dell’arte moderna. Sedlmayr è considerato il fondatore dell’analisi strutturale della storia dell’arte. Autore ancora oggi citatissimo, la cui analisi sulla rivoluzione dell’arte moderna è spietatamente veritiera tuttora. Sedlmayr analizza il perché di questa rivoluzione che c’è al principio di quella che lui chiama ancora arte moderna. (Sapete che sono ancora oggi molto difficili le distinzioni tra arte moderna e arte contemporanea, in particolare per quello che riguarda l’arte contemporanea, che teoricamente comincia ancora con il 1796 e giunge fino a questa mattina). Però lui parla di arte moderna, e si rende conto che i mutamenti di questa arte moderna sono stati compiuti in particolar modo da due gesti: il Quadrato Nero di Malevic, ossi l’azzeramento della pittura, e il famoso Object trouvè di Duchamp di cui parlammo già alcuni anni fa. Ma Sedlmayr sottolinea una cosa che molte volte noi dimentichiamo, ossia che l’atteggiamento che c’è dietro queste scelte, già allora, ossia già nella volontà di chi faceva questi gesti, era al di là dell’arte. Noi oggi prendiamo questi gesti come parte della storia dell’arte. In realtà, sia nelle motivazioni di Duchamp, sia nelle motivazioni di Malevic, c’è invece una volontà di andare al di là dell’arte, ossia gesti che non hanno nulla a che fare con l’arte e queste sono delle intenzioni che furono espresse dagli stessi autori. Questa considerazione è molto interessante, perché la troviamo praticamente identica dopo trenta o quarant’anni, in cui la storia dell’arte è andata avanti, ciecamente asservita, anche, agli apparenti richiami di una critica che invece di seguire l’arte, ormai la precede ed è assolutamente autonoma. Questa affermazione è confermata dal fatto che la maggior parte dei critici d’arte della maggior parte dei quotidiani e giornali nazionali nega l’esistenza di una pittura italiana.
Nella polemica intorno all’arte moderna, scrive ancora Sedlmayr, si dimentica oggi un fatto di capitale importanza, che cioè le estreme tendenze rivoluzionarie dell’arte non volevano più essere arte. Questo è il cuore pulsante, interessante delle avanguardie. Ma noi siamo rimasti qui, ossia, mentre le arti andavano per le loro necessità, per la loro necessità anche quotidiana di far parte della vita, delle cose, dai busti nei cimiteri, alle statuette che sorgono ogni giorno nelle rotonde della nostra riviera. Voi considerate che dalla trasformazione di cui parlava Rosenblum, alla rivoluzione, di cui parla Sedlmayr, il problema è esattamente lo stesso, ed è un problema che riguarda proprio l’“uscire dalla storia dell’arte”, l’arte che non è più arte.
E’importante allora chiedersi allora che cosa si voglia da questa arte, e in questo, appunto, vive anche l’ esperienza della Biennale. Se voi studiate la storia dell’arte degli ultimi trent’anni, la cosiddetta “dead of picture retoric”, la retorica della morte della pittura, è una frase che Robert Hughes, il grande critico d’arte australiano, usò negli anni settanta.
Nel 1998 una grande artista come Cecily Brown disse: “Provavo talmente piacere a dipingere che mi misero in condizione di smettere, così io feci”. Poi Cecily Brown, che è un’ artista inglese, insieme a molti arti artisti, ha continuato a dipingere.
Oggi in uno dei cataloghi della Biennale Arti Visive si legge questa premessa: “L’opera d’arte non è merce”. Noi ci troviamo di fronte a uno spaesamento assoluto, nel senso che – è quello che interessa a me dire qui e dimostrarvi – l’arte, nel senso nostro, nel senso anche tradizionale, ossia non solo l’arte come denuncia sociale, esiste, ma tutto quello che avviene intorno a noi cerca di dimostrarci che non esiste, che non esistiamo, e che, comunque, la nostra esistenza è un’eccezione.
Paul Virilio è un filosofo che si occupa in particolare di catastrofi, la filosofia delle catastrofi. Nel nostro mondo, cioè nel mondo delle cosiddette arti visive è abbastanza interessante il suo punto di vista, proprio perché Virilio non è uno storico o un critico d’arte, ma contempla questi azzeramenti studiati a tavolino con un interesse anche di tipo antropologico, perché si chiede fino a che punto si voglia andare, negando una realtà che esiste.
Voi sapete che l’espressione “complotto dell’arte” venne inventata dal compianto filosofo Baudrillard, che anche lui provenendo, come Sedlmayr, come Virilio, da tre scuole diverse, da tre pensieri diversi (sono tre giganti del pensiero del secolo scorso e di questo secolo), insieme si pongono la stessa domanda: perché dobbiamo continuare con questa bugia, con queste falsificazioni, con queste mistificazioni che sono sotto gli occhi di tutti?
Virilio usa le stesse parole usate da Sedlmayr cinquanta anni prima (il libro è del ’55; questo è del 2005 ed è stato tradotto nel 2007): “Violare, avvilire ciò che restava ancora delle regole artistiche, degradare le pratiche dell’arte profana come prima si erano profanate quelle delle varie arti sacre: tale era l’obbiettivo di un secolo spietato, di fronte non solo al martirio delle popolazioni civili, ma alla loro sensibilità sottoposta all’equilibrio precario di un terrore domestico dove la cultura contemporanea sarebbe ben presto divenuta, in un certo qual modo, il simulatore dello stupro delle masse. Realizzare un arte estranea all’arte, emancipare le arti plastiche, liberarle da ciò che costituisce, che le costituisce sono denominazioni diverse da una sparizione ‘progressista’ dell’estetica (…). Così, dopo la profanazione delle masse da parte delle propagande totalitarie, sembra venuto il tempo della profanazione della loro visione del mondo, in altri termini del loro orientamento spirituale”.
E’con grande costernazione che il filosofo si rende conto che siamo arrivati al punto che dopo avere creato la pittura senza immagine e dopo avere creato anche l’immagine completamente priva di qualunque volontà di rappresentazione, siamo arrivati al momento dell’artista senza opera, ossia dell’artista che chiude completamente con la produzione, per questo io mi chiedo se ci si possa avventurare in un campo che sarebbe il tema di oggi, l’“arte come conoscenza”. L’idea che l’arte esiste va coltivata da noi tutti, proprio da oggi pomeriggio, perché siamo in pochissimi a poterci permettere di continuare su questa strada.
Baudrillard, dal suo punto di vista, lamenta che quest’arte che ha appunto negato sia l’immagine sia l’artista, si è poi dimenticata di un terzo elemento che sarebbe colui che guarda. E quindi siamo tutti, diciamo, di fronte a questo annullamento; però, come vi dico, le opere ci sono e bisogna ricominciare ad avere il coraggio di guardare le opere d’arte e di considerare che non è soltanto un problema italiano, ma che la pittura, la scultura, il disegno in Italia esisteranno sempre, esisteranno finché ci siamo almeno noi che ne parliamo.
Concludo dicendo una cosa che mi piacerebbe fosse anche un augurio per tutti noi. In un libro bellissimo, che è “Il pittore della vita moderna” di Charles Baudelaire, ci sono affermazioni talmente reali e vive e contemporanee che sembrano scritte ieri. C’è una definizione del bello. Noi ancora pensiamo che la parola bello sia davvero la via alla conoscenza e la via della verità e noi pensiamo che sia possibile.
“Mi si presenta una buona occasione per fondare una teoria razionale storica del bello in opposizione a quella del bello unico assoluto, per mostrare che il bello ha sempre inevitabilmente una composizione doppia benché l’impressione che produce sia unica. Questo perché la difficoltà di distinguere gli elementi variabili dell’unità dell’impressione non annulla la necessità che ci sia una varietà nella composizione. Il bello è fatto di un elemento eterno, invariabile, la cui quantità è oltremodo difficile da determinare. E poi di un elemento decorativo di circostanza che sarà se si vuole di volta in volta l’epoca, la morale, la passione”.
Questa considerazione fa capire che nella ricerca di un bello apparente o semplice c’è quel dato comune che è alla base di tutti noi e che sarà quello che ci consentirà di ritrovare il bello nel futuro. Ma questa frase è identica alle considerazioni, per esempio, a ciò che scrive sull’idea del bello Platone. E se Platone e Baudelaire si ricongiungono in un’idea che è espressa chiaramente nel Fedone su questo doppio registro che ha la bellezza ma su questa necessità di riconoscervisi, se da Platone siamo traghettati fino a Baudelaire io penso che in questo nostro secolo si potrà realmente ricominciare a trovare proprio quel classico, in senso di classem, che poi non è altro che una flotta. Questo bello che è dentro ognuno di noi ed è un concetto semplice: è un ordine, lo stesso con cui noi mettiamo a posto i libri nella nostra biblioteca e non c’è nulla di strano ma penso che sia realmente più connaturato alla nostre vite che non quello che ci stanno volendo far credere. Grazie.
DAVIDE RONDONI:
Ringrazio la professoressa Buscaroli per questo viaggio tra date e nomi così lontani nel tempo, un viaggio di stupore e lotta, come avete sentito. Adesso andiamo al cinema, col professor Casetti che è uno dei maggiori esperti mondiali di cinema. Ero in Centro America, l’altro giorno, e quando ho fatto il nome di Casetti un paio di professori di una università sperduta del Venezuela mi hanno detto: “Come, Casetti?”. I suoi lavori sono conosciuti e studiati in tutto il mondo, lui insegna attualmente all’università Cattolica di Milano è Visiting Professor negli Stati Uniti. Lo abbiamo chiamato perché, conversando una notte in America, mi spiegava che stava lavorando esattamente su questo tema, appassionante per tutti, non solo per le giovani generazioni: che tipo di esperienza del reale, quindi, che tipo di avventura della conoscenza c’è nel vedere un film, cioè nel vedere qualche cosa che reale non è, ma del reale porta una traccia. Che tipo di esperienza stiamo facendo, vedendo come facciamo tutti, ormai, tanti film o comunque venendo raggiunti da tante immagini? Allora l’ho invitato e sono molto contento che sia qui con noi.
FRANCESCO CASETTI:
Grazie dell’invito, grazie a voi della cortesia di ascoltare. E’ la prima prova e io spero di superarla. Il professore Hollander si è domandato: “Come mettere un pagano tra cristiani?”. E la professoressa Buscaroli: “Come mettere una tradizione dentro una catastrofe?”. Io mi chiederò: “Come mettere un sapere dentro una distrazione?”, perché il cinema è quello: è il “dis-trarsi”. Parto da tre immagini che volutamente non mostro, perché appartengono al nostro immaginario collettivo. La prima è l’immagine chiave di Via col vento: tra il primo e il secondo tempo, c’è questa immagine in cui Rossella, disperata sotto l’albero della sua tenuta di Tara, invoca Tara, con il pugno alzato al cielo. Il carrello all’indietro ci mostra questo pseudo rosso, un rosso di tramonto. E’ un’immagine che tornerà alla fine del film, quando la disperazione si sarà trasformata nella perdita di tutto, Rossella ha perso il figlio, ha perso suo marito, ha perso il suo amore e ha perso colui che ha sposato. Sotto quell’albero non invocherà più Tara, ma dirà: “Domani è un altro giorno”. La seconda immagine è tratta da Roma città aperta, ed è l’immagine più tradizionale, la più classica: è la morte della Pina. La Pina, la Magnani, rincorre il camion su cui c’è Francesco, colui che lei avrebbe voluto sposare quella stessa mattina, arrestato dai tedeschi. Parte una raffica, lei cade a terra, il figlio vestito da chierichetto le si precipita addosso. Una morte tragica. La terza immagine è tratta da Guerre Stellari: ce la ricordiamo tutti perché ci sono le spade laser e il duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, che lui non sa essere suo padre, al termine del quale Luke perde una mano. Non occorre leggere Freud per capire che nel perdere una mano, quando lotti con il padre, qualche problema c’è. Tre immagini molto classiche, che pongono in qualche modo un nodo controverso per i loro protagonisti e per noi, che simpatizziamo con questi protagonisti. Sono tre momenti di smarrimento, di rottura. Uno, la prima immagine, uno smarrimento a cui Rossella cerca di sopravvivere, la seconda che porta la morte e il terzo che porta ad una ferita, ad una amputazione simbolica. E sono tre immagini, tre momenti di film che costringono questi protagonisti, di fronte ad un momento di rottura, di smarrimento, a chiedersi, magari nell’attimo della morte, chi sono, chi sono diventati, qual è la loro identità, il loro rapporto con il mondo. Io, che sono venuto su controversamente a lettura di avanguardie, in condizioni in cui l’arte che era datrice non c’è più, e altrove forse c’è ancora… ma anche, contemporaneamente, sono venuto su a Mogol e Battisti, e non posso che ricordare quei versi, quei quattro versi, scusami Rondoni, che sono un capolavoro della poesia italiana: “Ma come un’aquila può/ diventare aquilone/ che sia legata oppure no,/ non sarà mai di cartone,/ ah no,/ chi sono non so”. Sono tre momenti in cui noi, con i protagonisti, siamo di fronte a questo buco della conoscenza. Ma che risposta ci danno questi tre film davanti a questo buco della conoscenza? Ci offrono tre emblemi che affronterei come parabole, nel senso anche evangelico, che fissano questo smarrimento, questo buco che si deposita nella nostra testa, nel sapere collettivo. In qualche modo ci danno una conoscenza figurata, una parabola, in questo caso di uno smarrimento, di una domanda, che però, con una precisione straordinaria, fissa delle condizioni, ci fa rendere conto di ciò di fronte a cui siamo messi. Non si tratta solo di tre immagini che ci danno una icona concettuale, nessuno di queste tre immagini vive soltanto come concetto, spero di essere chiaro su questo, non sono degli algoritmi, sono immagini molto concrete. Quello che, ad esempio, a me sembra di poter rilevare, e che ha fatto sì che nella ricerca delle immagini, poi, abbia scelto queste tre, è la fisicità di queste immagini. Rossella è sotto quest’albero e invoca Tara, e c’è un carrello all’indietro – per chi si occupa di cinema, la macchina va indietro – che mi mostra tutto di colpo un cielo rosso. E’ come se lo spettatore ritornasse fisicamente nella sua pelle, con questo carrello indietro. Al contrario, Rossellini fa un camera car, come si dice, cioè un movimento di macchina in avanti: c’è la Pina, c’è questa sconvolgente immagine in cui la Pina, vestita da sposa, vestita bene perché si deve sposare, la gonna sollevata, il pizzo su di lei, morta. Questa macchina in avanti, al contrario, concretamente, fisicamente, ci porta a farci spettatori di una morte. E’ una macchina che ci porta a toccare la Pina, che trasforma l’immagine in qualcosa che possiamo toccare, qualcosa non soltanto di ottico. E infine, la terza immagine, Luke Skywalker che lotta con suo padre, non sa che è suo padre: è un trionfo degli effetti speciali, proprio la fisicità, se volete, della sensazione degli effetti speciali. Con un effetto curioso, che trasforma quello che è un dramma da camera, i conti che si regolano tra un padre e un figlio: lo trasforma in qualcosa che è una atmosfera da discoteca (vedi i raggi laser, le luci, eccetera). E’ questa fisicità delle immagini che gli interessa, questo sapere che ci viene dato, questa coscienza che ci viene restituita non con un algoritmo ma con un’immagine che ci percuote, che ci tocca, è una conoscenza incarnata nella fisicità del simbolo. E questo simbolo è trasparente, non è opaco, ma anche duro come un diamante, ci ferisce come la punta di un diamante. Aggiungo che questi tre simboli che ci vengono dati – Tara, la morte e la Pina, la mano mozza in un confronto perduto con il padre – sono anche tre simboli, non solo concreti fisicamente, che ci percuotono, ma sono anche tre simboli che si inseriscono dentro un racconto. Li abbiamo potuti raccontare, li abbiamo potuti mettere in una storia, come le parabole, per l’appunto: capacità del racconto, del simbolo narrativo di farci cogliere il reale, di portarci al reale. Leggo un pezzettino straordinario scritto da Michel de Certeau all’uscita di Play Time: “Lo spettatore improvvisamente nota l’umore delle strade come se esse avessero qualcosa a che fare con Tati (il regista di Play Time). Il film ha reso possibile un’osservazione veristica che senza questo film non si sarebbe prodotta. Ma allo stesso modo per la lettura di un poema, l’incontro con qualcuno, l’incontro con un gruppo: il registro della percezione, della comprensione si trova modificato, perché l’avvenimento ha reso possibile, ha permesso, in un senso molto reale un altro rapporto con il mondo”. Trovo straordinario questo pezzo. Hai incontrato come avresti potuto incontrare qualcuno, come avresti potuto incontrare un gruppo, hai incontrato un poema, un film, eccetera. E questo improvvisamente ha consentito nel racconto un altro rapporto con il mondo. Aggiungo anche, en passant, che questi simboli non soltanto hanno una loro straordinaria concretezza fisica, non soltanto sono delle narrazioni che permettono di raccontarci in un nuovo modo, una nuova maniera, il mondo, sono anche tutti e tre qualche cosa che hanno una loro storia e che fanno diventare la storia che raccontano, o il presente che raccontano, conoscenza consolidata. Confesso, amo molto Pasolini: in una disputa tra Pasolini e Calvino sono sempre stato di parte, dalla parte di Pasolini. Mi è sempre parso un barocco, l’altro. Ma comunque, c’è un pezzo, ne La religione del mio tempo, che dice esattamente questa cosa: “Quasi emblema, ormai, l’urlo della Magnani, sotto le ciocche disordinatamente assolute, risuona nelle disperate panoramiche, e nelle sue occhiate vive e mute si addensa il senso della tragedia. E’ lì che si dissolve e si mutila il presente, e assorda il canto degli aedi”. Dunque, tre cose, simboli molto concreti che mi percuotono, simboli che raccontano il mondo e ri-regolano il rapporto con la realtà. Simboli che, a partire dal presente – sono qui che vedo, e vedo quel che accade davanti a me -, lo trasformano in storia, lasciano spazio all’aedo. Queste sono le tre cose, e tuttavia le immagini che ho scelto non sono uguali. Ovviamente, non sono uguali. Sono scandalosamente diverse. E qual è l’elemento che le distingue tra loro? Non per compiacenza, ma per rispondere a un rebus, ogni invito deve essere anche una provocazione. L’invito di Rondoni mi ha costretto ovviamente, non solo a pensare, ma anche a mettere un pochino in questione certi saperi. Ebbene, cosa le distingue? Le distingue quella parola che Rondoni ha messo nel titolo, “l’avventura”. L’avventura che ha a che fare con l’avvenire, l’avvenimento. Ma lo dirò fra un attimo. L’avventura è quella cosa che avviene, che mi viene incontro e a cui io vado, consapevolmente o meno, incontro – le avventure si vivono, non si subiscono -, e che mi proietta in un avvenire di nuovo avvenimento, evento. L’avvenire che non è un futuro che io progetto, progetto-progresso, ma ciò per l’appunto che mi si para davanti e di fronte a cui io, probabilmente smarrendomi, devo fare i conti. Qual è allora la differenza tra le tre immagini? Che hanno un diverso grado di avventura, hanno un diverso grado di capacità di mettere in questione il mio rapporto con queste immagini e con la provocazione che esse fanno. La prima è una immagine che sintetizza, proprio nel suo essere cartesiana, sublimamente funziona da promemoria: l’invocazione a Tara non può che essere così. Anche la terza ha questa capacità di sintetizzare, inventando una nuova iconografia, ma in qualche modo andando su di un terreno consolidato, un rapporto tra un padre e un figlio, se non una sfida, che non può concludersi se non con una amputazione. Roma città aperta fa una terza cosa, un po’ diversa: rompe radicalmente con il passato, costruisce una iconografia che era in qualche modo invisibile, inconcepibile. Non si poteva dare prima ciò che Rossellini ci dà. A differenza di un riassunto, Tara, a differenza di una nuova iconografia su di un emblema consolidato, Guerre Stellari, qui abbiamo l’avventura di un pensiero che si butta in avanti verso l’avvenire, rischiando fino in fondo se stesso. Potremmo anche dire, come ipotesi mentale, perché no, che questa immagine, la morte della Pina, che ormai si è consolidata e che ci dà questa grande emozione, ma proprio per il suo rischio estremo, per la sua estremità nella capacità di provocarci e di metterci quasi nudi di fronte alle cose, potrebbe anche essere, come avrebbe detto Villaggio, una vaccata pazzesca. Perché ha ragione Villaggio, La corazzata Potemkin “è una vaccata pazzesca”, perché tutte le cose che rischiano l’indicibile sono insieme sublimi e “vaccate pazzesche”. Dobbiamo dircelo con franchezza, il sublime e la “vaccata” coesistono perfettamente. Roma città aperta rischia questa cosa, rischia l’aprirsi ad un terreno talmente nuovo che ad un certo punto potrebbe rivelarsi, appunto, una “vaccata pazzesca”. E, tuttavia, se è vero che un testo oltre che un bel sistema ordinato di segni, oltre che dal processo di scrittura, é quello che diceva un autore che qui non si cita tanto ma che a me sta tanto a cuore che è Foucault, che io leggo sempre insieme a de Certeau, perché erano molto amici ed erano esattamente l’opposto: un gesuita un po’ duro, l’altro un libertino, un po’ come lo spettacolo di ieri sera il Miguel Manara, un libertino intemerato. Foucault ci ha aiutato a ricordarci che i testi sono eventi, qualcosa che capita, di fronte a cui noi ci troviamo nudi e forse anche un po’ crudi. Ma questo trovarci di fronte ai testi come eventi, che ci lasciano nudi e crudi, è esattamente il senso di ogni evento. Qui faccio la retorica, perché cito la famosa definizione di Heidegger di esperienza, di evento: “Fare esperienza di qualcosa, si tratti di una cosa, di un uomo o di un dio, significa che qualcosa per noi accade che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge e ci trasforma”. Parlando di fare, non si intende affatto che siamo noi, qui, per iniziativa nostra o opera, a mettere in atto l’esperienza. Fare significa qui provare, soffrire, accogliere ciò che ci tocca, adeguandoci ad esso. Qualcosa si fa, avviene, accade. Questa è la celebre definizione di esperienza di Heidegger. Il testo è questa cosa, è qualcosa che noi non facciamo, accade. E di fronte a queste tre immagini, in diversa misura, questo noi facciamo, e di una di queste immagini facciamo più radicalmente che con altre. Ora, concludo, cosa è la radicalità di Rossellini, rispetto alle altre? In qualche modo, le altre due immagini mettono insieme, cercano di fare un acuto compromesso tra la sorpresa che ci coglie tra capo e collo, la conoscenza che ci accade, che ci avviene, e in qualche modo la ristrutturazione tranquilla del nostro mondo mentale, dopo che questa immagine ci ha scossi. Non so se sono chiaro, ci danno una scossa ma ci tranquillizzano. Rossellini non lo fa. Fa un percorso più complicato: ci dà una scossa, ci apre una domanda, non ce la chiude subito. Di fronte alle altre due immagini, in qualche modo, funziona così: “ho capito il gioco e vado avanti”. Di fronte a Rossellini: “ho capito il gioco ma la ferita è aperta, la Pina è morta”. Negli altri casi, “domani è un altro giorno”, ho perso una mano, me ne mettono una artificiale. La Pina è morta, non ci sarà più. Ecco, allora, la sfida è quella di mettere insieme evento, conoscenza e sapienza, attraverso strade un po’ più complicate. Non darcelo come una sorta di compromesso, non darcelo come il bignami della nostra vita: “stai tranquillo”. Diciamo, Rossellini non fa il talk show in cui il cronista ti dice: “sono bello, ma stai tranquillo”. Io non sto tranquillo per niente, ma questo è un altro paio di maniche. Rossellini ci percuote, ci apre una ferita e aspetta un po’ a chiuderla. La chiuderà, perché quella immagine ormai è dentro la nostra coscienza, ci ha aiutato a capire il mondo. Ci ha percosso ma, insieme, è diventata coscienza delle cose, attraverso un percorso lungo nel quale l’incontro non è stato fuggevole, l’incontro è stato duro. Rossellini, se volete, ha fatto quel percorso più lungo e complicato, quello che gli riesce disperatamente in una delle sequenze finali, che mi fanno sempre piangere, perché al cinema io piango anche un po’. Alla fine di New York, New York, che è di Martin Scorsese: vi ricordate il musicista, interpretato da Robert De Niro, che cerca di spiegare a sua moglie, interpretata da Liza Minelli, da cui sta divorziando, che non c’è spazio per la continuazione di un matrimonio, perché lui non riesce a trovare il magico accordo, lui che è un musicista, il magico accordo tra i soldi, l’amore e la musica? Lui dice: “Quando c’è la musica, ci sono i soldi, non c’è l’amore. Quando c’è l’amore, c’è la musica, non ci sono i soldi. Quando ci sono i soldi, non c’è la musica. Io vorrei fare il magico accordo e non ce la faccio”. Ebbene, Rossellini fa il magico accordo, non con la bacchetta magica ma con la fatica della nostra vita. Una volta si sarebbe detto che fare i magici accordi è un miracolo. Boh, forse i miracoli stanno dentro il nostro destino. Grazie
DAVIDE RONDONI:
Appare evidente anche dalla ricchezza dell’intervento del professor Casetti, per cui lo ringraziamo, che una vita umana che non faccia i conti con un incontro con l’arte, e anche con una riflessione sull’arte, è una vita che si condanna ad essere piatta come una sardina, piatta come qualcosa che non sente il gusto della propria profondità. Somiglia un po’, invece che al gusto della Nutella, a quella delle finte nutelle che danno in certi alberghi: choconut, chocolat. Una vita così, invece che originale! Però, come vi siete accorti anche dall’incontro di oggi, la preoccupazione del Meeting, la nostra educazione, non è quella di definire l’arte, come se sapessimo che cos’è e cosa non è. Perché l’arte è un fenomeno umano e patirebbe una definizione come una violenza. A noi non interessa definire l’arte, interessa seguirne l’accadimento, sorprendere quello che ci capita di fronte al rappresentarsi dell’arte in un film, in un poema antico o futuro come Dante o nell’arte contemporanea. Ci interessa questo. Per questo ci interessano persone come amici e maestri che ci aiutino a stare di fronte al fenomeno dell’arte. Ci aiutino, cioè, a fare questa esperienza che l’arte pone sempre in campo, del mondo che, attraverso il gesto di un altro uomo, ci parla, del segreto del mondo, avrebbe detto Ungaretti, che è un poeta leggermente meglio di Mogol. Perché “l’aquila e l’aquilone” è un po’ come “tre civette sul comò”. Dopo ne discutiamo a pranzo… Ma dicevo, come avrebbe detto Ungaretti, l’arte è il modo con cui il segreto del mondo si rilascia di fronte a noi. E facendo così, come avrete sentito in tutti e tre gli interventi, anzi, come è accaduto qui, dovendo ascoltare i tre interventi, facendo così eccita continuamente la nostra libertà. Perché l’avventura della conoscenza non è qualcosa che si può fare automaticamente, mettendosi su un binario belli, tranquilli e comodi e senza sorprese. E’ appunto un’avventura, cioè qualcosa in cui la libertà di cui siamo fatti viene continuamente provocata, eccitata, e così facendo, diventando più grande la nostra libertà, diventiamo più grandi noi come uomini. Per questo, in questi giorni di Meeting, dare un occhio ai tanti modi, alle tante forme con cui l’arte è presente qui, è sicuramente un investimento per diventare più liberi e quindi più grandi. Vi ringrazio per l’ascolto e soprattutto ringrazio i nostri ospiti.
(Trascrizione non rivista dai relatori)