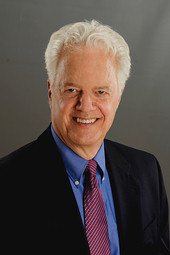CURARE QUANDO NON C’È POSSIBILITÀ DI CURA ALL’INIZIO E FINE VITA
Curare quando non c'è possibilità di cura all'inizio e fine vita
Partecipa Brad Stuart, Co-Founder and Chief Executive Officer of ACIStrategies (Advanced Care Innovation), USA. Introduce Elvira Parravicini, Assistant Professor of Pediatrics at Columbia University Medical Center, USA.
ELVIRA PARRAVICINI:
Buonasera a tutti, grazie infinite per essere qua. Io mi chiamo Elvira Parravicini, sono una neonatologa che lavora a New York e oggi ho questo grandissimo piacere di introdurvi un caro amico che è anche un grandissimo Professore, un americano, il dottor Brad Stuart.
Vi voglio dire due parole su chi è Brad: è medico da quasi 40 anni e dopo aver lavorato per molti anni come intensivista, ha deciso di creare una rete di Profit Management di cure avanzate, cioè per il trattamento di anziani e persone con malattie terminali, in modo tale da poter accudire queste persone nella loro casa, attraverso dei team di infermieri, assistenti sociali e altro personale. Questa rete comprende molti ospedali in America, un centinaio circa: ultimamente, Brad è il Chief Medical Officer della Coalition to Transform Advanced Care a Washington, perché sta progettando nuovi sistemi di cura che stanno rivoluzionando il trattamento dei pazienti e spera di trasmettere il suo modello a tutto il Paese. Questa innovazione per me è significativa perché, partita dal suo amore per la persona, adesso sta cambiando la struttura medica americana. Brad si definisce ateo però, malgrado lo scandalo della carne, il fatto cioè che, lavorando in medicina, vediamo il nostro corpo degenerare, riconosce che il rapporto umano è la sede del nostro incontro quotidiano con il Mistero.
Avremo una conversazione, io gli porrò delle domande e vediamo cosa succede. Iniziamo.
Parto con una premessa: ciascuno di noi si muove nella vita per dei bisogni e nella professione medica questo è ancora più vero. Io sono medico da più di trent’anni e capisco che la professione medica è un rapporto umano costituito da due bisogni, il bisogno di salute dell’ammalato e il bisogno dell’operatore sanitario di rispondere a questo grido d’aiuto del paziente. Il cuore del rapporto medico-paziente mi piace definirlo con la parola healing, un termine della lingua inglese che è piuttosto difficile da tradurre in italiano, perché significa “far guarire” o “curare”, però ha un connotato di attenzione, devozione, quasi di tenerezza che è difficile trasferire in italiano. Inoltre, credo che ci sia un healing per il paziente e uno per l’operatore sanitario, e che queste due esperienze avvengano nello stesso momento.
Vi faccio vedere questa miniatura del Medioevo che amo tantissimo perché, se guardate l’espressione dei volti, sia dei pazienti, sia degli operatori sanitari, vi accorgerete che hanno la stessa espressione, sono in tensione verso qualcosa, sono in tensione verso l’essere curati, gli uni, e il curare, gli altri. Io sono diventata medico per questa ragione e ho iniziato a fare la neonatologa proprio per questa ragione, perché in qualche modo volevo collaborare al compimento del destino di felicità per i bambini meno fortunati che nascevano con delle malattie gravi. A questo punto della mia vita, dopo più di trent’anni di professione, mi chiedo: ho veramente aiutato gli altri? Questo healing, è avvenuto per me e per i miei pazienti?
Ci sono stati tanti casi, come questo di questa bimba che è nata di 406 grammi, in cui questo healing è avvenuto totalmente: lei è stata in ospedale per sei mesi ed è riuscita a guarire, è andata a casa, è cresciuta. Qui nella foto ha tre anni e gioca con le sue amiche. Da questo punto di vista, posso dire che lei è viva per le cure ricevute, che io ho aiutato questa bambina a guarire. A questo punto mi voglio fermare un attimo. Faccio la mia prima domanda a Brad, voglio sapere che cosa pensa lui dell’healing. Cosa significa per te?
BRAD STUART:
Grazie. Prima di iniziare a rispondere alla tua domanda vorrei esprimere a te, mia cara amica e collega, e a tutti i presenti, il mio piacere, perché per me è un enorme privilegio essere qui e parlare a questo Meeting che per me personalmente ha un enorme significato, non solo come medico ma come individuo, come persona che avverte profondamente che il concetto di healing, di guarigione, ha molto a che fare con lo spirito, con l’anima della persona che ci è di fronte, di tutti coloro che sono all’interno di questa sala, e ha anche a che fare con il corpo. La bambina di cui ci hai parlato è stata curata e guarita. Si tratta di due processi diversi: la cura è ciò che noi medici siamo stati allenati a fare, si tratta di utilizzare la nostra mente per valutare il paziente, valutarlo attentamente, utilizzare tutta la nostra conoscenza, tutto ciò che è all’interno della nostra formazione, della nostra memoria, effettuare una diagnosi che sia corretta, decidere in merito al trattamento, somministrare questo trattamento. Se siamo fortunati e se siamo abili, allora il paziente guarisce. Il mio secondo commento riguarda la guarigione: dopo avere fatto questa attività per tanti anni, a volte sento – non per una mancanza di rispetto verso i medici – che la guarigione è tutto ciò che in realtà una scimmia molto intelligente riuscirebbe a fare, non implica una sorta di intuizione spirituale particolare o la consapevolezza dell’anima, non richiede il fatto di conoscere le proprie emozioni positive o negative. Tutto ciò non è necessario per la guarigione.
Siamo molto fortunati in questa esperienza, infatti ieri sera abbiamo trovato una citazione di Federico Fellini che dice: “Sicuramente noi discendiamo dalle scimmie però sfortunatamente non possiamo ritornare a quello stato”. Credo sia molto importante.
Dobbiamo andare avanti, oltre la conoscenza di ciò che è fisica e l’applicazione delle tecnologie. L’applicazione di tecniche e tecnologie specifiche che siamo stati allenati a fare è sicuramente importantissima ma non è tutto lì. Per tornare alla domanda di Elvira, la guarigione è un processo interno che avviene a livello profondo. Per ogni individuo, paziente o medico, visitatore, partecipante a questa conferenza, per ciascuno di noi, la guarigione corrisponde ad avvertire la presenza del sacro, di un noi più vero. Man mano che procederemo in questa conversazione, parlerò di più di questo aspetto del noi stessi che è, in realtà, il tema dell’intero Meeting: cos’è questa cosa che definiamo “io”? E vorrei distinguere questo aspetto nel contesto della guarigione, quale potrebbe essere la differenza tra l’io vero, che è la presenza di Dio in noi, e il sé, ciò con cui andiamo avanti, ciò con cui camminiamo ogni giorno, ciò che siamo. Credo che questo sia importante, che ci sia un io più profondo di cui possiamo diventare consapevoli. Ma è solo quando collaboriamo insieme, quando entriamo in connessione, quando ci coinvolgiamo all’interno della comunità, che possiamo insieme apprendere cos’è quell’io interno, chi è e chi siamo.
Quindi, per tornare alla domanda sulla guarigione: imparare ad essere un guaritore come medico, è un compito molto, molto più ampio, elevato, si tratta di una professione, di un mestiere molto più profondo che imparare semplicemente a guarire una persona. Come studenti di medicina, ci veniva insegnato che si può essere un buon medico, imparando a curare una persona, ma che non si sarà mai un grande medico finché non si imparerà a guarire una persona. La guarigione è un processo che si può descrivere come aiutare una persona, assisterla, affinché possa prendere consapevolezza, coscienza della propria anima, del proprio io più profondo e più intenso, molto più profondo del sé che noi riteniamo di essere quando camminiamo per strada, oppure siamo in ospedale.
Quando entriamo in questa connessione così profonda, spesso è un processo che non coinvolge le parole. Le parole sono spesso la presenza della persona, e allora possiamo partecipare al processo di guarigione. E qui, per fare una pausa, voi non sareste venuti a questa conferenza se non foste stati interessati ad essere guariti, a partecipare voi stessi in prima persona al processo di guarigione. Il processo di guarigione consiste nello scoprire che cos’è il nostro io più vero. Mi scuso perché in realtà tutto ciò che utilizzo sono parole, ho solo parole e le parole sono in realtà insidiose, esattamente come il sé è insidioso.
Vi faccio un esempio di quanto possano essere insidiose le parole. Farò un’affermazione e vorrei che poneste attenzione a ciò che andrò a dire. L’affermazione è la seguente: “Elvira e io siamo amanti”. Cosa intendo con questa affermazione? Non voglio far riferimento all’amore per così dire “normale”. Elvira è una bellissima donna ma il significato reale di ciò che io intendo con questa affermazione è più profondo della parola “amore”: Elvira ed io abbiamo avuto il privilegio di lavorare con tantissime persone che soffrono profondamente, così profondamente da riuscire a malapena a sopportare la propria condizione. Soffrono ad un livello così profondo che occorre trovare, al di sotto di quella sofferenza, un modo per trovare quelle persone, per trovare il vero io, quindi assistere, supportare quell’io affinché possa riemergere, affinché il processo di guarigione possa effettivamente emergere. Quindi, quando dico che Elvira e io siamo amanti, quello che intendo è che entrambi, attraverso l’esperienza, attraverso i tanti errori, abbiamo imparato ad amare. Sì, ovvio, ci amiamo, ci vogliamo bene perché facciamo lo stesso lavoro e quando due colleghi si trovano assieme, anche quella è una forma di amore. Però credo che sia lo stesso di amore di cui ha parlato Gesù, quindi l’amore di un essere umano per un altro, che deriva dalla compassione, dalla passione del conoscere, del sapere che siamo tutti assieme, che siamo un po’ tutti nella stessa barca, che siamo in questo processo e ci siamo insieme, siamo un team. Quindi, allo stesso modo, io ed Elvira siamo un team. La guarigione deve essere fatta, deve avvenire come in un team. Comunque siamo solo all’inizio, stiamo solo grattando la superficie della guarigione.
ELVIRA PARRAVICINI:
Grazie, Brad. Voglio continuare con l’esempio di prima per fare un altro passo. Questa è l’ultima foto di quella bimba di prima, che avete visto all’inizio. E’ molto brava, va a scuola, parla tre lingue, perché abita a New York, la sua mamma viene dall’America Latina per cui parla spagnolo e il suo papà viene dal Brasile per cui parla portoghese. Guardando le foto di questa bimba mi chiedevo: com’è possibile che io sia sempre così contenta di guarire un neonatino, soprattutto quando le possibilità di sopravvivenza all’inizio sono minime? Credo che la ragione sia perché riconosco che noi siamo fatti per l’eccezionale, vogliamo che ci succeda naturalmente quello che desideriamo di più e ogni volta che ci succede siamo tutti meravigliati. E per me, l’esperienza dell’eccezionale in medicina coincide appunto con questa esperienza dell’healing, per me e per il mio paziente.
Questo è il secondo passo: siamo fatti per l’eccezionale però non sempre succede. Vi introduco un altro esempio di una situazione di questo genere. Quello che mi colpisce, lo capirete nell’esempio, è che, nonostante questo desiderio non si compia apparentemente in modo totale, il desiderio rimane. Vi voglio raccontare in breve la storia di una bimba che si chiamava Rossella. Questa bimba è nata con una malattia del cervello gravissima, per cui non riusciva nemmeno a respirare da sola, aveva le convulsioni e, nonostante le avessimo dato un sacco di medicine anticonvulsivanti, le convulsioni non riuscivano ad essere trattate. Naturalmente ne parlavamo anche con la famiglia, in particolare con la mamma: cercavamo di parlare con lei per capire cosa potevamo fare per rendere la vita della sua bimba migliore, insomma, il meglio possibile. Alla domanda: “Cosa desideri per la tua bambina?”, la mamma ci ha risposto con un gran sorriso. “Ma che domanda mi fate! Io voglio che la mia bambina guarisca completamente e abbia una vita bellissima!”. Lì ho capito che questa mamma non cercava una consolazione o un compromesso, lei voleva tutto per la sua bambina e immediatamente mi sono trovata nella sua stessa posizione, come medico io voglio tutto per lei. Allora, questa è la mia seconda domanda per Brad. Cosa vuol dire rispondere a questo desiderio di tutto? I nostri pazienti ci chiedono la salute e vogliono la completa guarigione, noi lo stesso: come affronti questo nella tua pratica medica?
BRAD STUART:
Queste domande sono così facili, semplici davvero. Devo dire che quando ho cominciato il mio percorso in medicina, ho cominciato come un internista. Visitavo tutti i tipi di pazienti, facevo del mio meglio per cercare di individuare la loro malattia, perché la malattia cambia nel proseguo, evolve, per cui il mio obiettivo era mettere fine a questo processo, invertire questo processo. Questa è la vera cura, oggi. Sempre più spesso vediamo patologie che non possono essere curate, per esempio certi problemi di cuore, il cancro, il diabete. Non possiamo curare alcune malattie croniche. E quindi, quello che possiamo fare è semplicemente arrestare il progredire della malattia. Non possiamo veramente curare il paziente, al giorno d’oggi è inusuale trovare delle patologie, delle malattie che possono essere completamente curate. Abbiamo per lo più casi di malattie croniche che devono essere, senza dubbio, curate e seguite, ma non possono essere guarite. Come ci si sente come dottore quando ci si rende conto che questa persona di fronte a me, questo mio paziente con il quale posso avere una forte empatia, è una persona che non posso aiutare, una persona che non sono in grado di curare, e qualsiasi cosa io faccia questa persona è destinata a morire? Per molti dei miei pazienti, in questi ultimi vent’anni ho praticato la medicina palliativa: si trattava di persone spesso prossime alla morte. Prima di sapere cosa si può dire all’altro, bisogna guardarsi dentro e capire cosa si prova. So che questo è molto importante ed è difficile, perché ieri abbiamo parlato con alcuni studenti di Medicina. Cinque o sei studenti, dopo una conferenza, sono venuti da me. Uno ha avuto il coraggio di farmi la domanda, mi ha chiesto come far fronte ad una situazione in cui un paziente sta per morire e io non posso fare nulla per aiutarlo, come posso fare a superare questa sensazione di inutilità. Mentre diceva queste parole ha cominciato a piangere, evidentemente si è vergognato di essersi messo a piangere. Quando siamo studenti di Medicina e ci troviamo di fronte ad un Professore, non è certamente la cosa migliore da fare, quella di scoppiare in lacrime. La mia risposta è stata che quando si lavora con pazienti molto malati ci sono sempre dei sentimenti e delle emozioni forti. Prima ancora di ammettere con se stessi che stanno per morire, se lo fanno, perché fino alla fine molti non ammettono che stanno per morire, ma prima di poterlo fare c’è veramente un terrore, una paura enorme in queste persone. E questa è una delle tante emozioni che queste persone provano per cui, quando mi trovo a parlare con qualcuno a questo livello avanzato di malattia o con i suoi famigliari, e intervengono le lacrime, io credo che sia una cosa positiva, perché vuol dire che le sensazioni e i sentimenti sono arrivati in superficie e stiamo cominciando ad arrivare all’io interno, stiamo cominciando veramente ad avvicinarsi al vero io. Uno studente di Medicina che sta facendo il suo internato può volersi sentire molto forte, però è questo il modo in cui ci si pone di fronte allo studio della Medicina: bisogna essere sempre forti, mai mostrare debolezza. E invece le lacrime sono molto importanti, perché nessun essere umano può esser così forte, gli esseri umani che vogliono a tutti i costi essere forti sono dei pessimi guaritori. E’ difficile provare compassione e partecipare alla guarigione con indosso un’armatura, bisogna togliersi l’armatura. Francamente, posso dirvi – e lo può confermare mia moglie che è qui presente – che per me è stata una lezione molto difficile da apprendere, è più facile fingersi forti e grandi, il grande uomo americano forte. La mia risposta allo studente di ieri è stata: “Non posso prevedere il tuo futuro, ma ti posso garantire che hai tutto il potenziale per diventare non soltanto un buon dottore ma anche un buon guaritore, perché tu hai compassione, tu vuoi veramente guarire, arrivare a questo feeling. E questo senso di impotenza ti fa talmente male che non sbaglierai mai. Sarai quanto meno un bravissimo dottore e potrai essere un eccellente guaritore, perché hai delle emozioni e ammetti di essere impotente di fronte a certe situazioni, di non poter fare nulla da solo”. Un dottore che ritiene di avere tutto nelle proprie mani, di dover sopportare il peso da solo, di essere forte, di essere il grande medico che cura qualsiasi malattia, non può portare che danni, un accanimento terapeutico. E alla fine, questo tipo di dottori causano sofferenze, l’ho visto così spesso accadere. Solo nel momento in cui ci rendiamo conto che in fondo al nostro io di guaritori c’è la consapevolezza della nostra impotenza, che il risultato finale non dipende da noi, diamo il meglio. Una buona parte del processo di guarigione dipende da noi, è nostra responsabilità in qualità di medici fare sì che il processo di guarigione si evolva al meglio, fiorisca come una pianta. Se si cura una pianta, la si annaffia e la si protegge, la pianta fiorisce e cresce, ma non si può tirarla e afferrarla per farla crescere. Molti dottori ci provano ma è un grande errore, un errore che può causare molto dolore. Occorre capire, come un agricoltore o come un floricoltore, che il dottore deve fornire i mezzi, quindi deve piantare i semi, dare l’acqua alle piante, garantire un buon terreno ed aiutare le piante a crescere. Perché lo stesso succede per i medici: non dobbiamo essere passivi e rimanere lì a guardare cosa succede, questo significherebbe abbandonare il paziente che ha bisogno del nostro io, che ha molto bisogno di sentirci presenti.
Questo è quello che avrei voluto dire ieri. Come studente di Medicina si può sentire completamente impotente, non sa come fornire quella presenza che guarisce, ancora non lo sa, ma lo imparerà, lo imparerà vivendo una situazione dopo l’altra, un caso dopo l’altro, un paziente dopo l’altro. Si incontreranno i pazienti, si capirà chi sono, magari li si potrà aiuterà a capire se stessi. E tramite questo processo molti guariranno, non tutti, perché la volontà di guarire è assolutamente necessaria, non tutti vogliono guarire, ma coloro che hanno orecchie ascoltino, come diceva Gesù. Quando un dottore incontra un paziente che veramente ha una forza di volontà, un desiderio fortissimo di guarigione – possono essere malati terminali, malati di cancro – incontra quelle persone che andavano da Gesù e toccavano le sue vesti perché volevano essere guarite.
I miracoli che vediamo tutti i giorni – questo eccezionale di cui si parlava prima – forse non sono così straordinari, eccezionali. I più grandi miracoli sono spesso piccoli, bisogna tenere gli occhi e le orecchie ben aperte e soprattutto il cuore ben aperto per poterli vedere: sono piccoli eventi, piccole cose come ad esempio gli occhi di una madre che si illuminano, come diceva Elvira, quando capisce che sei lì per aiutarla e non semplicemente per somministrare qualche medicina, ma per ascoltare il paziente, per ascoltare quello che sente, perché l’ascolto è alla base della guarigione. Per concludere la mia risposta, credo che quando ci troviamo in una situazione come medici, come genitori, come fratelli, sorelle, padri, madri o qualsiasi altra cosa – non importa, non è necessario essere un dottore – possiamo però dare il potenziale di guarigione aprendo il nostro cuore, impotenti come siamo. Non siamo lì per risolvere il problema, siamo lì per incontrare una persona, siamo lì con il nostro cuore in mano per consentire a chi abbiamo di fronte di aprire il cuore e per permettere ai nostri cuori di incontrarsi. Lì la guarigione avviene, questo è il primo passo. Per concludere, posso dire che l’elemento più importante è questo. Se io sono un dottore e ho di fronte una persona che sta soffrendo profondamente, mi rendo conto che stiamo facendo dei progressi quando questa persona parla ed io ascolto, e poi dico qualcosa anch’io, semplicemente per dire alla persona che l’ho ascoltata. E la persona dice: “E’ esattamente quello che intendevo”, e il suo sguardo si illumina perché sa di essere stata ascoltata. Quindi, non è qualcosa che io faccio a questa persona ma qualche cosa che io aiuto a far venire fuori da questa persona. Ascoltare è importante ed è importante far capire all’altro che hai ascoltato: è il primo passo della guarigione.
Vi racconto una storia. Ero molto giovane, all’inizio della mia professione di medico, ed ero da solo all’interno di uno studio nella città in cui abitavo, circa 35 anni fa. Era domenica e stavo facendo dei turni in ospedale, visitavo i pazienti. C’erano con me altri cinque colleghi che facevano questo giro di visite. I miei figli erano molto piccoli e non desideravo altro che tornarmene a casa, per cui stavo facendo le ultime visite molto velocemente, per potere tornare a casa e mettere a letto i figli. Sono entrato nella stanza di questa paziente di un mio collega, soffriva di cancro. Leggendo la sua cartella clinica, ho visto che era sotto terapia perché il giorno successivo avrebbe dovuto iniziare un ciclo di chemioterapia. L’ho visitata, ho fatto quello che dovevo, poi l’ho guardata negli occhi. Era così infelice che mi sono fermato e le ho fatto una domanda, è sempre una buona cosa fare domande, non semplicemente dire ma chiedere. Le ho chiesto: “Come va?”. E lei ha subito capito cosa intendevo, non tanto chiederle se avvertiva dei dolori. Le stavo chiedendo, come persona, come individuo: come va, come ti senti? E mi ha risposto: “Malissimo, mi sento davvero male”. La mia replica è stata: “Perché?”. “Perché domani inizia la chemioterapia e non voglio farla, il tumore sta crescendo, il mio oncologo mi ha detto che il trattamento in realtà non lo rimpicciolirà, è l’unica cosa che mi rimane da fare, ma non voglio più farlo, sento che sono pronta a morire”. Non era triste, tutto sommato stava bene e nessun paziente, quanto meno negli Stati Uniti, deve essere sottoposto a dei trattamenti che non vuole, semplicemente ha il diritto di dire che non vuole essere sottoposto a quel trattamento. Lei mi ha risposto che la sua famiglia voleva che recuperasse, che migliorasse ma che in realtà lei non voleva essere sottoposta a questi trattamenti. Allora ho detto: “Lo sta facendo per la sua famiglia, anche se non vuole?”. La risposta è stata: “Sì”. Ancora una volta, ho pensato: non devo andare avanti con questa cosa perché mi porterà via tutta la giornata. Però la mia replica è stata: “Forse dovremmo parlare con la sua famiglia”. Lei mi ha risposto: “Sì, sono fuori che aspettano”. Sono uscito e ho visto che c’erano tantissime persone, era una giornata davvero impegnativa in ospedale, quel giorno. Per cui ho chiesto: “C’è qualche parente, qualche familiare della signora Smith?”. Si sono girate tantissime persone. Ho detto: “Ok, entrate”. E quattordici persone sono entrate nella stanza, alcune si sono sedute sul letto. C’erano quattro generazioni: i suoi genitori, suo marito, le sue sorelle i suoi fratelli, i figli e anche i nipoti. Addirittura, cinque generazioni.
Ancora una volta, mi sono guardato dentro e mi sono detto: è terribile, ci vorrà così tanto tempo. Ho detto: “Signora Smith, vorrebbe dire a tutti i presenti perché lei è qui e di cosa abbiamo parlato fino a qualche secondo fa?”. La sua replica è stata: “No”. “Ok”, ho detto io, “non sono il suo medico, è il mio collega che la segue, però la signora Smith mi ha detto che sente di stare arrivando alla fine della sua vita e non vuole sottoporsi al trattamento oncologico previsto per domani”. Non appena queste parole sono uscite dalla mia bocca, nessuno ha detto nulla. Poi, dal fondo della stanza, un uomo si è avvicinato a me, probabilmente aveva bevuto un po’, si è posto davanti a me, faccia a faccia, e il suo naso era davvero rosso. L’ha avvicinato molto al mio – in realtà io vi riporto questa cosa in maniera molto più carina rispetto a quanto abbia fatto lui – e mi ha detto: “Dottor Stuart, il suo compito non è quello di dirci che lei sta morendo, il suo compito è quello di farla migliorare”. Poi ha girato le spalle e se n’è andato.
Ho pensato: ho fatto un grande casotto, è terribile, perché in realtà non avevo idea di quello che stavo facendo. L’unica cosa che ho potuto dire è stata: “Guardi, ascolterò tutto quello che lei ha da dirmi ma non lasci questa stanza”. Lui stava per avvicinarsi alla porta, si è fermato, magari ha pensato tra sé e sé cosa fare, poi si è girato, è ritornato dalla mia parte, si è accasciato sul letto e si è messo a piangere, è scoppiato in lacrime. E a quel punto della mia carriera, io non mi rendevo conto di che cosa significassero le lacrime, per cui ho pensato di avere fatto un disastro, di avere in qualche modo aperto il vaso di Pandora, per così dire, di avere fatto la cosa peggiore possibile. E mentre pensavo questa cosa, tante altre persone all’interno della stanza hanno cominciato ad avvicinarmi, ho quasi cominciato ad avere paura. In realtà, mi hanno porto la mano, hanno voluto abbracciarmi o stringermi la mano, tutti mi hanno detto: “Grazie”.
Io ho pensato: grazie per che cosa? È un guaio, quello che ho combinato, perché mi stanno ringraziando? Per cui ho detto: “Di che cosa stiamo parlando in realtà? Non riesco a capire questa situazione”. E loro mi hanno detto: “La paziente era sposata, ha poi divorziato. Il marito si è allontanato ma la scorsa settimana è tornato a trovarla, quello è suo marito, il suo ex-marito. In realtà, da quando è tornato, lui è convinto del fatto che lei appunto migliorerà”. E’ un tipo di storia che ho riscontrato in tanti altri casi. Si sentiva così in colpa per come si era comportato nei confronti di questa donna, che probabilmente l’unica cosa che voleva era farla migliorare. Per lui sarebbe stato terribile se la sua ex- moglie fosse morta, per cui, sì, in qualche maniera era come se si fosse aperto il vaso di Pandora, si fosse scardinata una porta. Per cui, facciamo un piano, che cosa bisogna fare? Sappiamo tutti che lei non vuole sottoporsi alla chemioterapia però non abbiamo potuto dire nulla, non abbiamo potuto nemmeno chiedere, in realtà. Adesso possiamo parlare di questa cosa. Quindi, abbiamo cominciato a discutere e in cinque minuti abbiamo elaborato una sorta di piano.
Il giorno dopo l’oncologo è stato davvero sollevato, perché neanche lui volevo sottoporre la sua paziente al trattamento, la paziente stessa era sollevata, quindi è andata a casa con la famiglia accanto a sé. Dopo tre settimane è morta in pace, circondata dalla sua famiglia. Successivamente sono venuto a sapere che per tutte le persone coinvolte si è trattato di un processo di guarigione. Quindi, questa storia è semplicemente l’esempio di tante storie simili: semplicemente, non abbiate paura di porre domande, prima lezione. Seconda lezione, ascoltate attentamente ciò che vi si dice. Ascoltate e basta. Terzo: siate preparati a sorprendervi, lasciatevi sorprendere. Pensavo che la sorpresa che mi aspettava fosse terribile e in realtà non è stata affatto terribile, è stata meravigliosa. Con l’esperienza, con la pratica di questo tipo di soluzioni, mi sono reso conto che nella gran parte dei casi possono accadere cose interessanti e molto buone, quando si agisce in modo onesto, quando si chiede alle persone che cosa veramente vogliono, quando si aiutano le persone a fare ciò che effettivamente vogliono, non ciò che vogliamo noi ma ciò che vogliono loro.
Poi, per tornare alla risposta, ho appreso che quando non c’è nulla che si può fare per guarire una persona, si può comunque cercare di curarla. Questa è una situazione che accade da sé, dal momento in cui io sono entrato nella stanza fino al momento in cui l’ho lasciata. Saranno passati, non so, venti minuti. In quei venti minuti, dopo quei venti minuti, sono andato a casa, ho cenato, ho raccontato questa bella storia ai miei figli.
ELVIRA PARRAVICINI:
Grazie di questo bellissimo esempio. Dagli esempi, è ancora più chiaro come healing sia tenere conto del cuore, cioè del tuo cuore che desidera tutto per il paziente e, anche in una domenica, decide di andare fino in fondo. Introduco un altro concetto, poi ci sarà un’altra domanda, perché sono convinta che tutti, dato che siamo essere umani, abbiamo lo stesso cuore, dottori, infermiere, mamme e papà, pazienti. La mia esperienza è che il cuore è la risorsa più grande per vivere, per affrontare la vita e soprattutto i momenti più difficili della vita. A questo riguardo, vi voglio raccontare una breve storia. Io imparo tutto dai miei pazienti, per cui racconto tutti questi esempi. Ho incontrato una ragazza, immigrata dall’America Latina, che aspettava un bimbo. I dottori le avevano detto che questo bimbo sarebbe probabilmente nato con delle malformazioni gravissime al cervello, per cui aveva deciso di abortire. E siccome nel Paese dove lei vive l’aborto non è permesso, era venuta a New York dove aveva delle sorelle, per fare l’aborto. Attraverso strade complicatissime, che non sono mai a caso, è arrivata fino a me, perché voleva chiedere il mio parere. Cosa posso fare io? Quando ho sentito tutta la storia e mi sono trovata questa ragazza di fronte, ho pensato una cosa sola: il cuore è la risorsa, per cui, per aiutarla a decidere cosa fare, mi appello al suo cuore di mamma.
L’ho fatta parlare, ho seguito il consiglio di Brad. Le ho detto: “Raccontami la tua storia, perché sei venuta fino qua”. E lei mi spiega che è una femminista, che crede nei diritti della donna, per cui ha deciso una certa cosa e vuole andare fino in fondo. Ad un certo punto, le dico: “Anche io credo nei diritti della donna, c’è tanto abuso nel trattare le ragazze, le donne, ha perfettamente ragione”. E aggiungo: “Però, sai, io sono una neonatologa, lavoro con i bambini, credo nel diritto dei bambini”. Eravamo in una stanza dell’ospedale dove lavoro e dalla finestra vedevamo la stessa scena che voi vedete sulla diapositiva, cioè tutta Manhattan alla sera, al tramonto. Era bellissimo.
E le dico: “Guarda fuori, non credi che il tuo bambino magari abbia il diritto di vedere questa cosa così bella, oppure di conoscere la sua mamma, che in fondo gli vuole bene, o la sua famiglia?”. Di fronte a queste domande, lei, che comunque era una ragazza molto semplice, istintivamente risponde: “Sì, hai ragione”. Poi si ferma, capisce la gravità di questo sì e rimane in silenzio.
Allora le ho detto: “Dai, andiamo a vedere i bambini”. L’ho presa e abbiamo iniziato a camminare nel mio reparto di terapia intensiva, dove abbiamo più di 70 bambini, molti dei quali sono delle stesse dimensioni del bambino che lei portava in pancia. Comincio a dirle: “Questo potrebbe assomigliare al tuo bambino, ma è un maschio, una bambina…”. Abbiamo camminato per più di un’ora avanti e indietro. Più camminava, più mi poneva domande: “Ma questo bambino, come mai è qua? Tornerà a casa? Chi sono la sua mamma e il suo papà?”. Alla fine di questo pomeriggio passato insieme, mi saluta, mi dà un grande abbraccio e mi dice: “Le volevo dire che io questo bambino lo voglio vedere vivo, lo tengo”. E lì ho capito che il cuore della mamma ha vinto, non ho dovuto dirle “fai questo, fai quell’altro”, ho semplicemente risvegliato in lei quello che era più vero. A quel punto, lei tornava in America Latina: mi ha detto che avrebbe partorito e mi avrebbe mandato delle foto. Con questo esempio, introduco un’altra domanda a Brad: che esperienza hai tu del cuore come risorsa nella tua professione?
BRAD STUART:
Un’altra ottima domanda, solleverò un punto di cui abbiamo già parlato. Tra noi medici si parla spesso di come possiamo curare meglio i nostri pazienti. Ecco, se leggiamo questa domanda in questo contesto potremmo dire: come possiamo usare il cuore dei nostri pazienti come una risorsa? E’ un po’ come nella storia che hai raccontato. Elvira ha fatto appello al cuore di madre della ragazza, e la ragazza ha cambiato idea e ha preso un’altra strada. Elvira ed io parliamo spesso e abbiamo parlato anche del cuore del medico come risorsa, perché non c’è solo quello del paziente. Partiamo da qui, poi vediamo dove arriviamo.
Il 90% dell’istruzione che il medico riceve praticamente trova la sua strada soltanto nella mente: c’è una formazione del cervello, della mente, ma non c’è una formazione del cuore, o molto poco. Quando sono venuto in Italia, speravo che le cose fossero diverse da come sono negli USA. Io ho studiato ormai 40 anni fa e nel mio Paese ancora oggi gli studenti arrivano alla facoltà di Medicina con grandi ideali. Molti studenti dicono cose del genere: “Voglio diventare un dottore e guarire la gente”. E’ questo desiderio di guarigione che li ha attratti verso la medicina. Sono state fatte delle ricerche su questo, la formazione medica americana mira, in un certo senso, a far scomparire questo tipo di tensione verso la guarigione negli studenti. Quindi, dopo cinque o sei anni di Medicina, dopo l’internato, ecc., abbiamo dei grandissimi tecnici, molto preparati ma che hanno dimenticato come era il loro cuore cinque anni prima. Questa è una situazione molto comune. Allora mi sono detto: “Bene, andrò in Italia e là, di certo, le cose sono diverse, è un Paese che tende sempre alla bellezza. Per me e per mia moglie questa è la prima volta in Italia e la prima cosa che mi ha colpito è che sembra quasi che la ricerca della bellezza – tirare fuori la bellezza dalle situazioni, dalla gente – sia l’obiettivo principale della vita.
E’ una cosa che si nota immediatamente, quando si arriva per la prima volta in Italia. I bambini sono bellissimi, tutti i bambini sono veramente belli. Poi ti guardi intorno, guardi gli adulti e dici: “Diventeranno ancora più belli, crescendo, se fanno come i loro genitori”. La bellezza è un’istituzione, in Italia, è un principio organizzatore della vita. D’ora in poi, quando sentirò le parole “la dolce vita”, saprò cosa significano in termini di una bellezza che pervade la vita. Quindi, pensavo che venendo qui avrei scoperto che la formazione medica in Italia rispecchiava questi valori e che quindi il cuore sarebbe stato molto più importante per uno studente di quanto non sia negli Stati Uniti. E una studentessa americana che ho incontrato ieri ha detto la stessa identica cosa: “Noi arriviamo con il nostro cuore aperto, pronto, ma poi tutto questo viene in un certo senso soffocato, messo da parte”. Questo succede anche qui.
Ecco, perché credo sia importante porsi questa domanda, qual è il ruolo del cuore del medico? Posso rivolgermi a tutti voi, posso rivolgermi direttamente ai vostri cuori, ma cercare di rompere l’armatura che riveste il cuore di un medico sarebbe veramente una cosa meravigliosa in tutto il mondo. Vi faccio un altro esempio: quando ero un internista, incontrai un paziente. Prima si fa la facoltà di Medicina, poi c’è questo periodo di internato: ero appena diventato dottore. Ho incontrato un paziente che sarebbe diventato un mio paziente: si chiamava Bob. Gli era stata diagnosticata la leucemia, una malattia del midollo spinale, del sangue, che porta molto spesso alla morte. Aveva già fatto un ciclo di chemioterapia ma poi la malattia si era ripresentata ed era quindi di nuovo in ospedale per un secondo ciclo di chemioterapia. La chemioterapia per la leucemia è molto difficile da sopportare. I medicinali sono così forti perché l’obiettivo è distruggere il cancro che si trova nelle cellule del midollo spinale, quindi in pratica viene colpito tutto quello che c’è all’interno del midollo spinale, e si incrociano le dita e si spera che le cellule buone sopravvivano. Insomma, è un po’ una roulette russa. Bob era pronto per affrontare la sua seconda chemioterapia, quando l’ho incontrato la prima volta. Mi cadde l’occhio sulla sua giacca appesa al muro, era un giubbino di pelle piuttosto sporco, sopra c’era scritto “Hell’s angels”. Era un motociclista, Bob, membro degli “Hell’s angels”, appunto, una nota gang di motociclisti. Insomma, ero un po’ spaventato, mi faceva quasi paura: gli mancavano diversi denti, non era il tipo di persona che ero solito frequentare. Vicino a lui, c’era la sua ragazza, Key, che aveva una pettinatura afro ed era veramente molto, molto bella e molto affezionata a Bob. Col passare del tempo, Bob stava sempre peggio e Key un giorno mi prese in disparte e mi disse: “So che Bob sta per morire e vorrei che ci sposassimo qui, all’ospedale”. Quindi chiamammo un prete e ci fu questa cerimonia, proprio intorno al letto perché Bob non riusciva ad alzarsi, era ormai troppo debole. Vennero tutti i suoi amici, grandi e grossi, con le catene attaccate alle giacche, ai giubbini di pelle, insomma, un gruppo un po’ particolare, però andavamo tutti d’accordo. Stavamo cercando di conoscere meglio Bob, per me era difficile perché era completamente diverso dalle persone che ero abituato a frequentare. Un giorno entrai nella sua stanza e lui stava leggendo una rivista di motociclismo, la più famosa negli Stati Uniti, con una grossa motocicletta sulla copertina. Mi disse: “Ehi, dottore, venga qui”. Mi sedetti di fianco a lui sul letto, oramai eravamo diventati amici. Mi mostrò la pagina centrale della rivista, c’era una fotografia bellissima su due pagine di una meravigliosa motocicletta con il manubrio alto, tutta luccicante. E sulla motocicletta era semisdraiata una donna completamente nuda con le mani sul manubrio, era bellissima, tutta ben truccata, ma svestita. Ed aveva questi capelli molto voluminosi, rossi, era Key, sua moglie, e quella era la motocicletta di Bob. La rivista di motociclismo aveva pubblicato questa foto della sua motocicletta e di sua moglie. E questo per lui era stato un evento importantissimo, era veramente felice. Mi guardò e disse: “Non è bellissima?”. Non so se parlasse di sua moglie o della motocicletta o della situazione o di che altro. Ma mi sono detto: non importa! Quello che conta è che Bob sta per morire ma in questo momento è felice, festeggia, è sinceramente felice. Mi sono detto: io penso a Bob come al mio paziente che sta per morire. Non c’è più molto che posso fare per lui e mi sento impotente come tutti gli studenti di Medicina. Ma in quel momento mi sono detto: aspetta un attimo! Il fulcro della situazione è la gioia di Bob, è questo che conta, non la sua leucemia. Non è il fatto che morirà, che conta, ciò che conta è Bob, il cuore. E quindi mi sono reso conto che, nonostante io mi fossi preoccupato moltissimo per Bob e fossi così dispiaciuto per lui e per Key, in quel momento il mio cuore era colmo di gioia. E quindi ho capito che devo prestare attenzione al mio cuore, così come presto attenzione al cuore dei miei pazienti. E devo cercare di individuare il momento in cui il mio cuore si apre e la mia guarigione ha inizio. Quel giorno sono stato guarito della mia paura della leucemia. Da lì in poi, ogni volta che ho incontrato un paziente affetto da leucemia non mi sono mai più sentito come mi ero sentito all’inizio con Bob. Credo che la morale della storia sia questa: alla base della guarigione c’è il cuore, solo attraverso il cuore possiamo trovare noi stessi e trovare la nostra comunione con il paziente. Lì la guarigione ha inizio.
ELVIRA PARRAVICINI:
Ringrazio Brad per quest’ultimo esempio che non conoscevo ancora e che ci riporta al fatto che noi vogliamo tutto per il nostro paziente. Ma che cos’è questo tutto? È il momento del compimento, della gioia. E a questo riguardo vorrei tornare all’esperienza di Rossella, la bambina di cui vi detto prima, che ci ha posto questa domanda: come fare perché la mamma sia accontentata nel suo desiderio di tutto per lei? Seguendo e imitando quello che Brad ci diceva prima – ogni volta non sappiamo quello che succederà – dobbiamo seguire qualcun altro nella realtà. Io dico sempre ai genitori dei miei bambini: seguiamo il tuo bambino, ci porterà da qualche parte e vedremo di sicuro qualcosa di bello e di vero. Con la piccola Rossella, sapevamo che la sua vita sarebbe stata breve, però non sapevamo quanti minuti, quante ore, quanti giorni. Quindi abbiamo deciso di stare con lei per la durata della sua vita, sapendo che in quel momento lei poteva godere dell’amore della sua famiglia e anche del nostro, e noi potevamo godere di lei. La sua vita è andata avanti giorno dopo giorno, fino al momento in cui improvvisamente il suo cuore si è fermato e sua mamma ha dato indietro a Colui che l’aveva creata la sua bambina. Ma la sua esistenza è stata un’esistenza totalmente felice, amata e desiderata da tutti. Per cui, io posso dire che l’esperienza della vita di Rossella è stata un momento eccezionale. Voglio farvi ancora un paio di esempi in cui capisco che l’eccezionale ci sta con qualsiasi situazione. Guardate queste foto: nessuno potrebbe immaginare che in queste foto ci sono due fratellini con una sorellina che sarebbe morta quattro ore dopo. E potreste chiedermi: che importanza ha una bimba che vive per quattro ore? Anzi, molti mi direbbero: perché l’hai fatta vedere ai fratellini? Loro potrebbero soffrire di questa cosa, avere dei traumi, sarebbe stato meglio non fargliela vedere nemmeno. Beh, guardate la prossima foto, sono i suoi fratelli otto anni dopo. Questa foto è stata scattata al convegno annuale che faccio nel mio ospedale per insegnare il comfort care agli americani, ai medici e alle infermiere. Avevo invitato la mamma a parlare della loro storia ma quando i suoi figli, due ragazzi a questo punto teenager, hanno saputo che la mamma veniva, sono voluti venire anche loro, proprio per raccontare come è stata importante la presenza della sorellina nella loro maturazione di adolescenti, e anche per raccontare il fatto che la loro famiglia – mamma, papà e loro due -, poco dopo la morte della sorellina, ha dato inizio ad un’associazione per conoscere e aiutare le famiglie nella loro stessa condizione. Per cui, posso dire che, in questo caso, anche qui la piccola Margherita ha vissuto una vita eccezionale perché ha cambiato la vita di molti.
Un altro esempio, questo è un piccolo bambino che è vissuto anche lui pochissimo, poco più di un’ora, nove mesi nella pancia della mamma e poco più di un’ora fuori al sole. Anche qui, noi sottolineiamo una cosa importantissima, che qualsiasi sia la lunghezza della vita di un bambino, prima della morte c’è la vita, e allora vogliamo goderne appieno, per cui addirittura abbiamo portato la torta con le candeline. A questo punto, ho un’ultima domanda velocissima, perché abbiamo pochissimo tempo, per Brad, riguarda questo punto, prima della morte c’è la vita: che esperienza hai di questo nel tuo lavoro?
BRAD STUART:
Dunque, sì, prima della morte c’è la vita, c’è vita fino a quando non arriva la morte. Oltre la morte non sono abbastanza saggio da sapere cosa ci sia. Credo tuttavia che noi abbiamo la responsabilità di fornire le migliori opportunità alle persone che serviamo, affinché queste persone possano vivere la migliore vita possibile nel modo in cui vogliono viverla. Fino a quando possono farlo, fino all’ultimo momento della loro vita. Credo che possiamo fare molto di più come medici nell’esercizio della medicina, dell’assistenza sanitaria affinché questo effettivamente si realizzi. Infatti, spesso mi viene chiesto di parlare del lavoro che faccio negli Stati Uniti. Molti anni fa ho smesso di vedere i pazienti uno ad uno e ho incominciato a lavorare per esempio nei reparti di cure palliative, per lavorare con più persone piuttosto che incontrarle faccia a faccia, singolarmente. Ora lavoro con un’organizzazione a Washington D.C. che si occupa di trasformare il modo in cui il trattamento viene somministrato nell’ambito del sistema sanitario a persone fortemente malate, cercando di portare assistenza alle persone esattamente dove vivono, affinché i pazienti non debbano venire a vedere noi medici, ad esempio, negli ambulatori o in ospedale. Possiamo portare gruppi di infermieri o medici a casa del paziente, indipendentemente da dove abita, e non solo a casa. Ci sono persone che abitano per esempio in hotel, ci sono tanti senzatetto, ci sono delle residenze, cerchiamo di portare assistenza in queste sedi, cerchiamo di incontrarli con il cuore, formiamo il nostro personale affinché faccia esattamente questo e organizziamo il trattamento sanitario affinché questo serva le esigenze dei pazienti. Abbiamo avuto dei risultati molto positivi, non solo in termini di miglioramento dell’assistenza che queste persone ricevono ma anche in termini di riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria. Perché se le persone non devono tornare in ospedale – spesso non vogliono tornarci -, i costi si riducono, perché gli ospedali sono appunto la sede in cui si sostengono i costi più elevati. Queste persone riescono a vivere la vita che vogliono fino al loro ultimo respiro. Potrebbe essere un modo per offrire assistenza sanitaria in futuro negli Stati Uniti e anche in altri Paesi. Ancora una volta, voglio dire che per me è stato un privilegio essere qui con voi, amiamo essere con voi e quindi sono molto, molto grato ad Elvira. In realtà, non ti avevo mai visto così, senza il camice bianco sei davvero professionale! Vorrei semplicemente incoraggiare tutti a trovare assieme la guarigione e a vivere nel migliore modo possibile, fino all’ultimo momento che possiamo.
ELVIRA PARRAVICINI:
Due parole velocissime di conclusione: volevo farmi portavoce di quello che Brad ci ha lasciato, con il ricordo di questo piccolo quadro. E’ un ricamo che una mamma ha fatto per la culla del suo bambino nel mio ospedale. C’è scritto: “You are loved”, che vuol dire “Tu sei amato”. Volevo semplicemente farvi notare una cosa. Questa mamma non ha scritto “I love you”, cioè “Io ti amo, ti voglio bene”, ma “You are loved”, perché questa mamma ha capito che anche tutto l’amore che aveva lei non era in grado di salvare la vita del proprio bambino, ma si è anche resa conto che c’era qualcun altro che invece poteva portare a compimento e far succedere l’eccezionale. Direi che la mia esperienza nel mio lavoro e l’esperienza di Brad portano nel cuore proprio questo, perché questo è quello di cui ha bisogno quel bambino, quella mamma e anche noi come operatori sanitari: uno che ci ami sempre e senza fine. Per cui, vi lascio con questo messaggio perché, anche se non siete dottori, la questione della vita è la stessa.